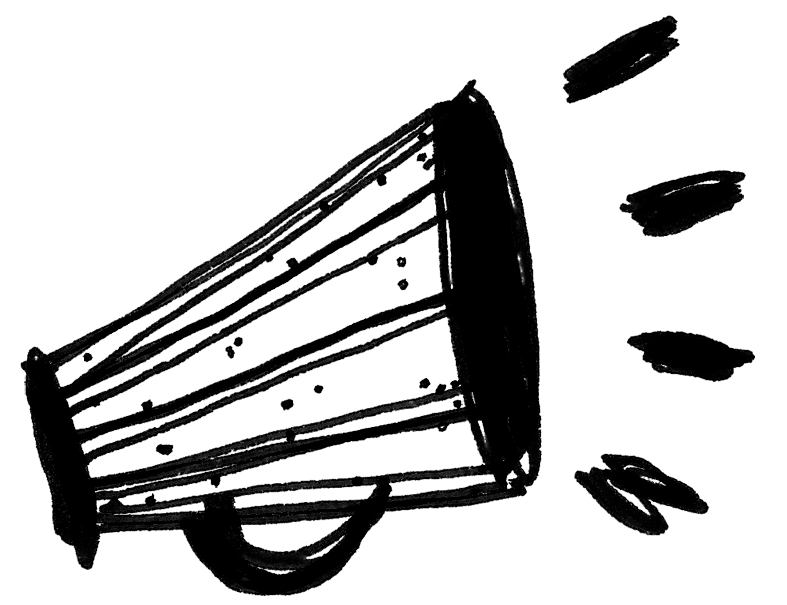Tutta un’altra storia
Intervista a Rutger Bregman
Una “profezia che si auto-avvera” è un modo di dire, ma anche l’idea secondo cui basta esprimere una previsione affinché questa si realizzi. Se qualcosa di simile accade non è da imputare a ragioni sovrannaturali, ma al fatto che, a volte, le nostre convinzioni sono così forti da spingerci a comportarci come se fossero vere, tanto dal volerne quasi fornire la prova. Così, per esempio, la narrazione in cui ormai crediamo ciecamente, che ci dipinge come individui egoisti, noncuranti degli altri e dell’ambiente, ci guida nel compiere scelte che non possono che partire da quelle inevitabili premesse.
Se provassimo a presentarci ai nostri stessi occhi in modo diverso, a riporre una maggiore fiducia nel genere umano, non prenderemmo decisioni migliori? Non ci sentiremmo forse all’altezza di più alte aspettative e non troveremmo soluzioni migliori?
Di questo, e non solo, abbiamo parlato con Rutger Bregman, autore di Una nuova storia (non cinica) dell’umanità.
Vorrei cominciare questa intervista a partire dalla fine del libro. Mi ha molto colpito il paragrafo dedicato alla regola d’oro, condivisa tanto dai filosofi della storia occidentale quanto da genitori e insegnanti. Dalle tue parole si intuisce che la giudichi leggermente difettosa: come mai?
La regola d’oro può essere espressa in due modi. Ne abbiamo una versione positiva, che recita: “Tratta gli altri come tu vuoi essere trattato”; nella sua forma negativa, invece, suona così: “Non trattare gli altri come non vorresti essere trattato”. In ogni caso, la regola d’oro è fondata sull’idea che gli uomini, in quanto simili tra loro, abbiano gli stessi bisogni, desideri e sentimenti e questo, chiaramente, non è vero. Il solo fatto che le persone abbiano gusti diversi è sufficiente a comprendere che vorrebbero essere trattate differentemente le une dalle altre.
Al giorno d’oggi tutti parlano di empatia, definendola la soluzione a tutti i nostri problemi. Spesso, però, se ne fraintende il significato: essere empatici non vuol dire essere in grado di provare ciò che un individuo diverso da me sta provando come se le differenze tra me e l’altro si potessero facilmente annullare; essere empatici significa fare lo sforzo di metterci nei panni di una persona, che è essenzialmente e irriducibilmente diversa da me: è pericoloso dimenticarci che l’altro è differente, che ha bisogni, desideri e sentimenti che non necessariamente coincidono con i miei.Quando ci si relaziona a un altro individuo, è fondamentale porsi una domanda: che cosa desidera, che cosa preferisce la persona che ho di fronte? Ecco perché, alla fine del paragrafo che menzionavi nella tua domanda, cito Bernard Shaw e la perfetta sintesi che ha fatto di quella che da alcuni è definita la regola di platino: «Per prima cosa chiedi alle altre persone che cosa vogliono, perché potrebbero avere desideri diversi dai tuoi; non trattarle come tu vuoi essere trattato, perché sono essenzialmente diverse da te». In generale, credo che sarebbe meglio non dare per scontati i sentimenti degli altri, pensare di conoscerli senza ombra di dubbio; al contrario, sono convinto della necessità di fare domande, conversare e dialogare di più.
Nel libro provi a spiegare la ragione che spinge le persone buone a comportarsi male e arrivi a sostenere che l’empatia e la xenofobia sono due facce della stessa medaglia. Perché?
La questione è davvero interessante e, per affrontarla, vorrei partire da un punto di vista biologico, prendendo in esame un ormone abbastanza famoso e che ha un ruolo fondamentale durante la gravidanza e al momento del parto: l’ossitocina. A volte se ne parla come dell’ormone dell’amore o delle coccole, perché fa sì che le persone siano tra loro simpatiche e amichevoli. Insomma, l’ossitocina rende possibili alcuni tra i nostri comportamenti più meravigliosi. Tuttavia, recenti ricerche hanno messo in luce come l’”ormone dell’amore” abbia anche un lato oscuro e sia alla base dei nostri atteggiamenti xenofobi.
Si è scoperto, per esempio, che persino l’amore per il nostro bambino può avere un legame con la xenofobia di cui siamo capaci. Ricerche svolte in ambito sia biologico sia neurologico hanno evidenziato come le madri non siano e non sappiano essere particolarmente empatiche. O meglio, riescono a esserlo solo nei confronti della loro prole, su cui, alla stregua di un riflettore puntato, si concentra tutta la loro empatia. Qualcosa di simile accade quando, per esempio, in un notiziario o un documentario la macchina da presa inquadra insistentemente un’unica e specifica persona sofferente, provocando in noi un immediato sentimento di empatia e uno spontaneo desiderio di fare qualcosa per lei. E intanto, sullo sfondo, il resto del mondo, ignorato, continua a soffrire. Basta pensare che ogni anno circa 45 milioni di bambini muoiono di malattie che sarebbe facile curare, come la diarrea o la malaria: su di loro, però, non ci sono riflettori puntati, non ci sono video che mostrano insistentemente quello che accade. Per noi è più semplice concentrarci su un giovane malato oncologico che appartiene a una nazione ricca, poiché esistono moltissimi video struggenti che li ritraggono al fine di raccogliere fondi per aiutarli. Ovviamente, non voglio criticare questo tipo di operazione, perché è chiaro che anche un bambino malato nato e cresciuto nella società del benessere meriti di essere aiutato. Intendo solo sottolineare il fatto che anche i restanti 45 milioni di bambini presenti in tutto il mondo dovrebbero ricevere le medesime attenzioni da parte nostra.
Insomma, il più delle volte l’empatia non è una luce che illumina il mondo intero, ma un riflettore che lascia nel buio tutto ciò su cui non si direziona. Ecco, dunque, il lato oscuro di un sentimento così tanto elogiato: l’implicito ignorare gli Altri che non cadono nel nostro campo visivo. È evidente anche nei conflitti e nelle guerre, dove il meccanismo è sempre lo stesso: comprendiamo i nostri amici, ma siamo ciechi nei confronti dei nemici, che ci limitiamo a detestare, dai quali vogliamo solo ottenere vendetta e dei quali non ci sforziamo di comprendere la prospettiva. In una parola, l’empatia porta con sé anche la xenofobia. A mio parere, non dovremmo lavorare sull’empatia: è di più compassione che abbiamo bisogno. Sono due sentimenti molto diversi (anche a livello neurologico, stimolano due aree distinte del cervello)1. Se sei un genitore, quando tuo figlio è spaventato per via del buio non vuoi provare empatia, non vuoi condividerne la paura: vuoi invece consolarlo e rassicurarlo sul fatto che il buio non è pericoloso. La compassione è più controllata, distaccata e costruttiva: non porta a partecipare della sofferenza dell’altro, ma aiuta a vederla per poi entrare in azione.
Tutti i manuali di pedagogia rivolti ai genitori insistono sull’importanza di non assegnare etichette ai propri figli per evitare di ingabbiarli in un agire stereotipato, corrispondente alle aspettative – negative o positive che siano. Nel tuo libro sembra che sia l’intero genere umano a essere vittima dell’etichetta negativa che si è auto-imposto. Ci sono, nel corso della storia dell’uomo, esempi di come proprio la rottura o il rifiuto di una simile etichetta abbia permesso il superamento di momenti di crisi?
Il messaggio più importante che volevo lanciare con il mio libro è proprio questo: da una persona otterremo ciò che ci aspettiamo da lei. Se pensiamo che un dato individuo sia per natura pigro ed egoista, lo tratteremo convinti che ci risponderà con quell’atteggiamento e, in questo modo, creeremo proprio il tipo di persona che ci aspettiamo che sia.
Se guardiamo al mondo dell’educazione e, più precisamente, al modo in cui è stata pensata la didattica nelle scuole, appare evidente la presentazione negativa che il genere umano ha fatto di se stesso. Fino a oggi ha prevalso il punto di vista cinico: chi lo assume vuole una scuola ieratica e competitiva, in cui i bambini, seduti tutto il giorno sulla loro sedia, non distolgono mai l’attenzione dall’insegnante, che, a sua volta, segue precisi programmi e impone agli studenti determinati insegnamenti. Che cosa accade, invece, se partiamo dall’idea che i bambini siano perlopiù curiosi e vogliano crescere in collaborazione con amici e compagni?
Nel libro dedico un intero capitolo2 a una scuola organizzata proprio a partire da questi presupposti. Per prima cosa, laddove tradizionalmente la scuola separa e divide, qui tutto è mescolato: bambini di età e livelli di preparazione diversi si incontrano e collaborano, imparando gli uni dagli altri. Non esistono programmi, perché gli interessi sono diversi e ogni bambino ha la possibilità di seguire e approfondire i propri.
Quando ho sentito parlare di questa scuola per la prima volta, ho pensato che avrei trovato bambini pigri attaccati tutto il giorno ai videogiochi: mi sono figurato una specie di disastro. Mi sono dovuto ricredere: esistono in tutto il mondo diversi esperimenti analoghi che dimostrano che una simile impostazione funziona e che i bambini non sono pigri, se non vengono trattati come tali. La scoperta più interessante è che in questo tipo di scuola non esiste il bullismo, che evidentemente non si verifica naturalmente: noi adulti, pur facendo il possibile per evitarlo, siamo in realtà convinti che il bullismo non si possa eliminare del tutto e che si tratti di un fenomeno connaturato alle relazioni che si intrecciano nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Non è così: il bullismo è il prodotto di un modello scolastico e istituzionale e, a seconda del tipo di scuola che si propone, è perfettamente evitabile. Mescolare i bambini e i ragazzi, per esempio, fa sì che ciascuno, proveniente da un differente background familiare, sociale e culturale, appaia nella sua unicità e diversità, mentre, al contrario, nelle scuole tradizionali la struttura è così rigida da classificare gli studenti secondo gerarchie e competizione: il bullismo tra bambini e ragazzi è spesso e volentieri il riflesso di questo secondo modello.
Se cambiamo la visione che abbiamo del genere umano, riconoscendo come alcuni tratti negativi non siano connaturati alla nostra specie, quanto, piuttosto, qualcosa di creato dalla società, possiamo prendere decisioni e agire in modo radicalmente diverso.
In generale, può essere interessante concentrarsi sui luoghi in cui si consumano i nostri peggiori comportamenti. Abbiamo fin qui fatto l’esempio del bullismo, che, però, non si verifica solo nelle scuole: episodi simili accadono anche nelle prigioni e nelle case di cura, tutti luoghi dove non permettiamo alle persone di vivere liberamente, ma secondo strutture rigide e precise gerarchie che instaurano un clima di competizione. Le cose, però, non devono per forza andare così.
Il tuo libro è ricco di esempi che prendono in considerazione bambini e ragazzi: il capitolo in cui descrivi la scuola sperimentale non è il solo. Qual è la ragione della tua attenzione verso i più giovani? È forse a partire da loro che è possibile riscrivere una nuova narrazione della storia umana, che abbia risvolti non solo teorici, ma, come hai raccontato, anche molto pratici?
Alla cultura occidentale appartiene una vecchia idea, la Veneer Theory, secondo cui la civilizzazione non è che un sottilissimo strato che nasconde la vera e profonda natura umana, caratterizzata da egoismo. Sulla base di questa teoria la civilizzazione – fatta delle istituzioni politiche, della scuola, dell’esercito, etc. – ci ha permesso di sfuggire alla nostra vera e odiosa natura.
Ritroviamo quest’idea nella filosofia antica, nella dottrina cristiana, per la quale siamo tutti peccatori, o nel pensiero che è alla base della fondazione degli Stati Uniti d’America e secondo il quale l’uomo è una creatura essenzialmente egoista; in particolare, John Adams, filosofo e secondo presidente degli USA, è autore di un testo intitolato “Tutti gli uomini sarebbero tiranni, se potessero”. Nel diciannovesimo secolo, a seguito della formulazione della teoria dell’evoluzione in biologia, si diffonde la corrente di pensiero nota come darwinismo sociale, che applica i principi della lotta per la sopravvivenza e della selezione naturale alle società umane. Infine, c’è il capitalismo, che vive sulla convinzione secondo cui le persone siano egoiste e l’avidità sia “cosa buona”.
Stando così le cose, è facile riconoscere come ci sia stata continuamente proposta una visione che descrive il genere umano come fondamentalmente egoista. Di fronte a una tale insistenza, sarebbe stato davvero difficile non finire per crederci. Io, però, credo sia una narrazione completamente sbagliata e adesso abbiamo tantissime prove che lo confermano: dalla biologia all’antropologia, dalla psicologia alla sociologia, gli studi sembrano suggerire che il genere umano sia molto meglio di come ci è sempre stato presentato. E penso che il modo più potente di dimostrarlo sia proprio guardare ai bambini.
Per molto tempo gli psicologi erano convinti che i bambini non fossero altro che egoisti più giovani, ma una ricerca estremamente interessante di un gruppo di scienziati tedeschi ha messo in luce come già bambini di due o tre anni sappiano essere molto collaborativi tra loro. Il professore di psicologia Felix Warneken ha curato una selezione di video su YouTube che mostra un bambino molto piccolo che, intento a giocare con un mucchio di palline colorate, si accorge dell’adulto che all’improvviso irrompe nella stanza e compie delle azioni molto discrete ma che rendono evidente il suo bisogno di aiuto: il bambino comprende e abbandona la sua attività per raggiungerlo e soccorrerlo. È davvero improbabile che, a questa età, il bambino abbia potuto apprendere un simile atteggiamento altruista ed è più verosimile che un gesto del genere sia compiuto naturalmente. Se questo fosse vero, potremmo a buon diritto sostenere che siamo legati da buoni sentimenti e siamo portati a essere collaborativi. Altri studi, svolti su bambini di sei mesi, dimostrano che questi giovanissimi umani sono in grado di distinguere tra giusto e sbagliato e di preferire il primo al secondo.
La civiltà non è un costrutto artificiale: lavorare insieme ci appartiene; possiamo – e dovremmo – aver fiducia nella nostra natura. Nel libro mi sono divertito a parlare del Signore delle Mosche: per decenni abbiamo raccontato e insegnato a milioni di bambini che, se si fossero trovati a vivere su un’isola deserta, sarebbero diventati dei selvaggi e avrebbero compiuto azioni terribili. La realtà dei fatti, però, dice il contrario, come dimostra quanto accaduto davvero ai giovani naufraghi dispersi sull’isola di Ata a sud dell’Arcipelago di Tonga. Perché credo sia importante tutto questo? Perché una storia non è mai semplicemente solo una storia: ha sempre un intento o, comunque, un risvolto nella vita vera. Se continuiamo a dire ai bambini che la maggior parte delle persone inganna o è egoista, impareranno a considerare così non solo gli altri, ma anche loro stessi.
Dobbiamo cambiare, è necessario costruire un mondo differente. Per farlo, dovremmo cominciare a raccontare ai nostri bambini e a noi stessi un nuovo tipo di storie.
NOTE
1 «[…] La dottoressa poté vedere subito la differenza sullo schermo del computer, che mostrava l’attività di reti cerebrali diverse: mentre con l’empatia era soprattutto l’insula anteriore, situata sopra l’orecchio, ora si trattava del corpo striato e della corteccia orbito frontale.» R. Bregman, Una nuova storia (non cinica) dell’umanità, p. 319.
2 Ivi, p. 242

Rutger Bregman (1988) è uno storico. Utopia per realisti (Feltrinelli, 2017) e Una nuova storia (non cinica) dell’umanità (Feltrinelli, 2020) sono tradotti in più di quaranta lingue. Entrambi sono stati nella classifica dei bestseller del “New York Times”. Per il suo lavoro al quotidiano online “De Correspondent”, Bregman è stato nominato due volte per il prestigioso European Press Prize. Vive in Olanda..