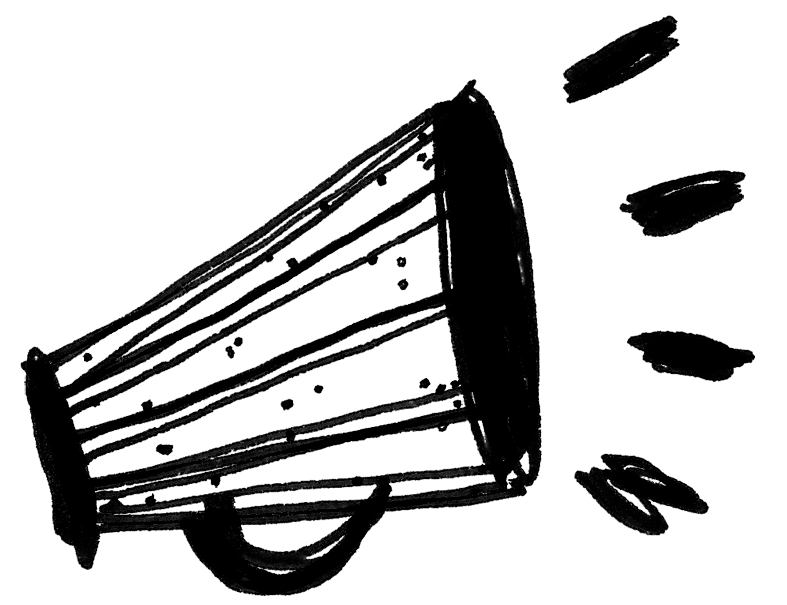Non darti troppe arie!
Articolo a cura di Danilo Faravelli
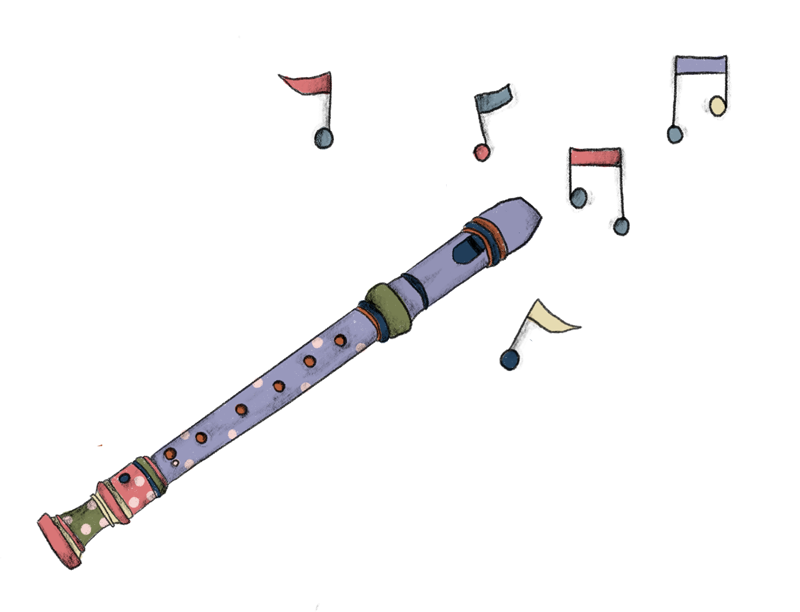
Nell’arte vocale, specie in quella praticata con finalità teatrali entro i confini di genere del melodramma, l’aria, in quanto depositaria delle più raffinate e pregevoli poetiche del dilatarsi della parola in canto, costituisce il luogo per eccellenza dell’ostentazione del talento musicale d’ugola.
È l’aria a fornire al belcantista il terreno e l’occasione del perseguimento del successo di palcoscenico. Nessuna primadonna, nessun Orfeo, nessuna Didone, nessun don Ottavio, nessun Tancredi cercherebbe l’applauso di conferma della propria bravura in un pur mirabile terzetto, quartetto, finale d’atto o altro “numero chiuso” d’assieme; né tantomeno, rimanendo alla tipologia delle esibizioni a solo, si aspetterebbe ovazioni calorose dopo aver concluso un recitativo secco o un recitativo istromentato o un arioso.
È l’aria il banco di prova della voce operistica smaniante gloria immortale, o meglio intossicata di vanagloria.
Senza uscire dal territorio della musica d’arte, concedendoci uno sguardo solo un po’ al di là dei suoi confini, verso il mondo della comunicazione quotidiana, chiediamoci che cosa possa esserci se non la vanagloria alla base di una delle più celebri metafore mutuate dalla sfera operistica. Che cosa significa “darsi delle arie” se non credersi chissà chi e non perdere occasione per cercare di irretire l’animo altrui in siffatta convinzione?
Il modo di dire funziona a meraviglia se, di fronte alla sensazione di pena mista a disgusto che suscitano in noi certi palloni gonfiati tipo “Lei non sa chi sono io!” torniamo con la mente, d’istinto, ad alcuni applauditissimi tenori perennemente a caccia di idolatri e tiranniche soprano specialiste in capricci impossibili da soddisfare.
La metafora, tuttavia, mostra anche la corda di un’inammissibile contraddizione se nell’aria cogliamo, come è giusto che sia quando il suo fluire sia stato alleggerito di ogni virtuosismo, il luogo vocale del sommo bene della semplicità, identificato dai più grandi artisti come la meta ultima e il valore supremo del proprio agire creativo.
Se così non fosse, come spiegheremmo la scelta dell’ormai anziano Bach di affidare all’elegante candore di un’aria ripresa dal quaderno di esercizi di cembalo composto per Anna Magdalena, sua seconda moglie, il ruolo di essenza melodica su cui innalzare il poderoso edificio di metamorfosi sonore delle Variazioni Goldberg?
Analogamente non sapremmo come spiegare la celestiale innocenza dell’Arietta posta da Beethoven sordo, sofferente e stoicamente rassegnato all’inclemenza del proprio destino, a sigillo dell’avventura compositiva della sue trentadue sonate per pianoforte, forse la più sconvolgente e temeraria delle rivoluzioni attuate dal combinarsi in un unico soggetto umano di immaginazione e intelligenza musicale.

Danilo Faravelli, nato nel 1953, si è appassionato alla musica d’arte negli anni dell’adolescenza. Sin da subito ha preferito consacrarsi a una prospettiva interdisciplinare del culto a cui si sentiva vocato: anziché sognare di diventare virtuoso della tastiera o dell’archetto, si è avventurato per anni in esperimenti alchemici miranti a combinare l’Arte dei Suoni con la prosa letteraria, il teatro, la poesia, la corporeità, il gioco, i piaceri della tavola e la pittura.