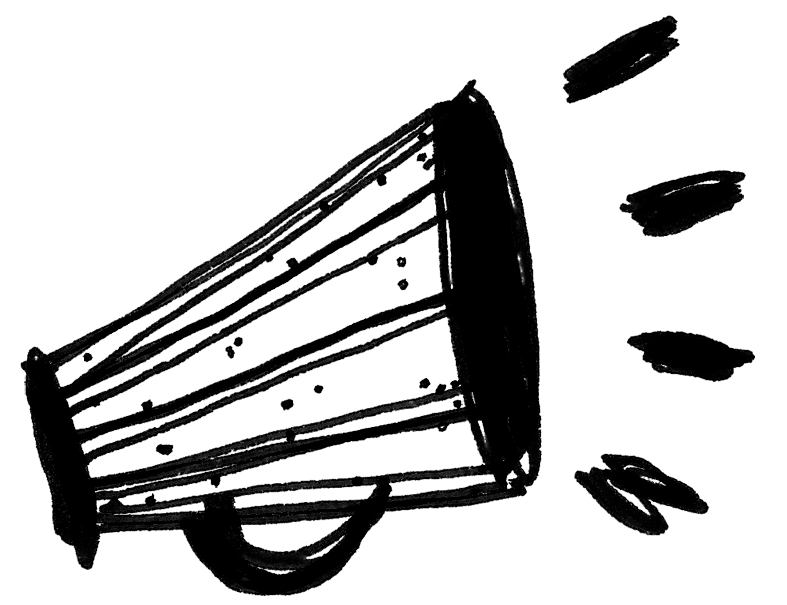Non-centro
Intervista a Chiara Valerio a cura di Pietro Corraini
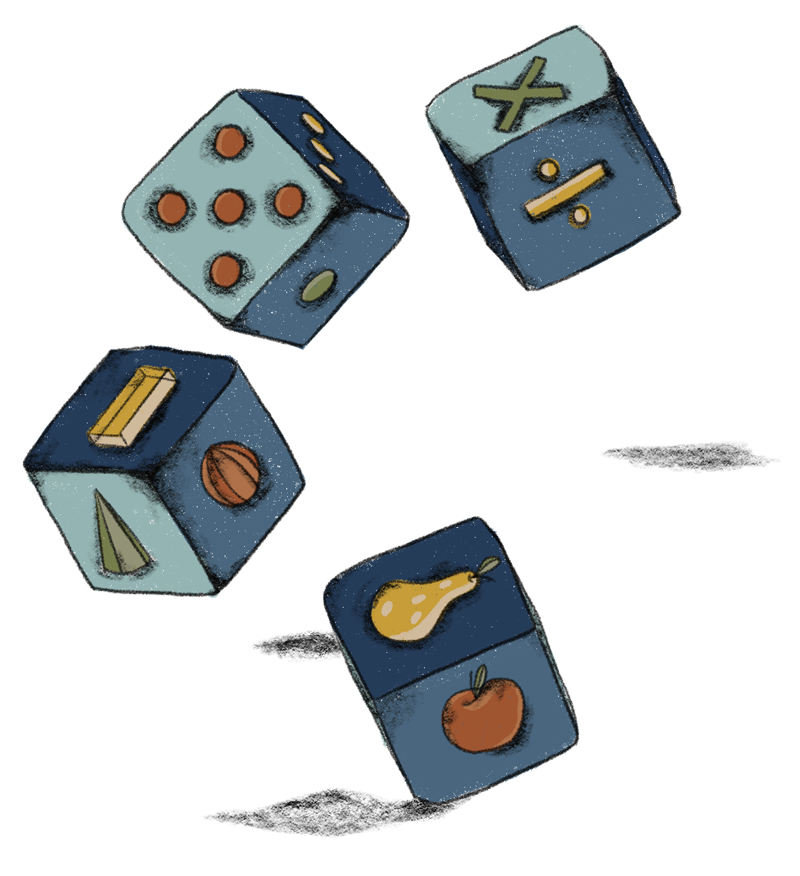
Che cosa c’entra la matematica con la politica? Uno sguardo più attento di quello che il luoghi comuni ci suggeriscono vedrebbe che le due discipline hanno moltissimi punti in comune. L’intervista a Chiara Valerio, autrice di La matematica è politica, ci porta ad aguzzare la vista.
Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con la scuola: mi è sempre piaciuto andarci. Alle elementari avevo un maestro che nel corso dei quattro anni (io mi unii alla mia classe in seconda, perché avevo fatto la primina) ci ha insegnato essenzialmente le quattro operazioni e la geometria solida, decisamente più pratica rispetto alla geometria piana. La mia non era una scuola steineriana o montessoriana, ma una normalissima scuola statale di provincia in un paese del basso Lazio e il mio maestro, il maestro Nicola, sicuramente non era laureato: semplicemente, per insegnarci la matematica, ci faceva giocare con i solidi e ci mostrava le relazioni tra i numeri. Questo è stato il mio primo incontro con la matematica, che ho conosciuto come qualcosa con cui fosse possibile giocare e non come una montagna da scalare. Ricordo che nelle ore di matematica facevamo continuamente plastici: sviluppavamo il cubo, il parallelepipedo, i prismi. Il nostro paese non vantava costruzioni architettoniche particolari e le casette che potevi vedervi somigliavano a quelle che disegnano i bambini, sostanzialmente parallelepipedi sormontati da prismi, proprio come quelli che sviluppavamo noi durante le ore di matematica: nei piccoli diorami che il maestro ci faceva fare potevamo ricostruire in piccolo il paese in cui abitavamo. Molto probabilmente, è da qui che è nata in me l’idea che la matematica fosse una disciplina che si poteva costruire volta per volta e che, quindi, non aveva nulla a che fare con la verità, ma, piuttosto, con la possibilità; l’idea che la matematica fosse qualcosa di esperienziale.
Alle scuole medie, poi, la mia professoressa di Storia dell’Arte, che credo fosse laureata in architettura, sin dal primo anno ci abituò a fare disegni in prospettiva, che, anche se poteva apparire un modo univoco di rappresentare la realtà, non lo era affatto: al contrario, una volta capito il meccanismo, la prospettiva ti permette di cambiare il punto di vista.
Perciò, in realtà, per me la scuola è proprio il luogo in cui la matematica mi è stata presentata come qualcosa di giocoso, di esperienziale, e che, in effetti, aveva a che fare con la rappresentazione del mondo nel modo più semplice possibile: vedi la casa, fai la casetta. Tutto il contrario rispetto a quella montagna insormontabile, quel marasma di formule, quel linguaggio simbolico a cui faticosamente devi accedere per capire le cose. Grazie al modo in cui avevo potuto conoscere questa disciplina a scuola, non avrei mai potuto avere difficoltà nei confronti della matematica, che per me era visibile e, di conseguenza, toccabile. Ecco, credo che questo sia sempre stato il mio approccio: la matematica non era un sostrato invisibile, ma era nella realtà, che è mutevole: come poteva quindi la matematica avere a che fare con la verità assoluta?
Al liceo le cose si sono fatte più complesse e al triennio ho conosciuto la matematica come verità assoluta: è così che mi sono stati presentati i numeri reali e complessi di cui si compone l’analisi matematica standardizzata che si studia in quegli anni di scuola, senza che però mi venisse detto qualcosa di fondamentale e cioè che quelle verità si portano sempre dietro un contesto. Se me l’avessero detto, avrei capito immediatamente ciò che invece ho impiegato un po’ di anni a comprendere: che quelle verità sono assolute e immutabili solo in riferimento a un contesto e che, quindi, non sono dei macigni inamovibili, indiscutibili, e tutti gli altri aggettivi che iniziano per “in-“ che ci vengono in mente.
Questa consapevolezza ti rende molto forte: ti conforta nell’idea con la quale sei cresciuto, ovvero che le verità esistono, ma sono relative; sono sempre assolute e sono sempre relative, perché esistono in un tempo e in uno spazio. Ecco perché le verità matematiche sono così simili alle verità umane: tutte le nostre verità, le verità sentimentali, hanno a che fare con un contesto, quindi con una relazione.
Ecco, diciamo che a scuola, dal punto di vista geografico, sociale, provinciale, posso dire di essere stata fortunata: la matematica per me non è mai stata autoritaria. Mai.
Il maestro Nicola di cui ti parlavo era il mio unico maestro: stava con noi cinque ore al giorno per quaranta settimane all’anno. Probabilmente non capita mai più nella vita di stare così tante ore con una sola persona ed è innegabile che l’insegnamento sia legato moltissimo alla persona che ti insegna, vista la quantità di tempo che passi con lui o con lei. Ecco, se questa persona, come il mio maestro, è qualcuno che vive nella possibilità e, soprattutto, in un atteggiamento di attenta curiosità nei confronti di ciò che il mondo può dare, il risultato è che per cinque ore al giorno, per quaranta settimane all’anno, tu ti senti ripetere che il mondo è l’insieme delle possibilità. Un’affermazione praticamente equivalente a quello che dice Wittgenstein quando sostiene che il mondo è l’insieme delle sue rappresentazioni, nessuna esclusa: nemmeno quella di un bambino piccolo, che, anche se meno specifica e meno approfondita, esiste insieme a quella di tutti gli altri.
L’insegnamento è necessariamente legato alla persona: gli esseri umani imparano in presenza di un racconto e se chi racconta non fa propria una visione autoritaria, l’idea che passa è che la conoscenza non sia qualcosa di autoritario. È grazie alla persona che insegna, insomma, se la conoscenza è intesa come qualcosa che dà, sì, competenza, autorevolezza e anche un merito rispetto a certe cose, ma, soprattutto, un metodo, che è sempre la curiosità.
Oggi, nell’insegnamento della matematica, si commette un gravissimo errore: la si presenta del tutto scollegata dal presente vissuto volta per volta dagli esseri umani. È come se la matematica fosse considerata fuori dalla storia e il risultato è che non si capisce perché si abbia l’esigenza di un concetto piuttosto che di un altro o perché siano necessari duemila anni per svilupparne uno. La matematica non dovrebbe essere insegnata prescindendo dal suo legame con la religione, con la politica o con la storia, perché fare così equivale a dichiararla una disciplina fuori dall’umano, meramente astratta.
Intendiamoci, la matematica è una disciplina astratta, esattamente come tutte le grammatiche che, però, poiché nel parlare sappiamo di usarle continuamente, ci sembra che abbiano un risvolto pratico più evidente. Al contrario, abbiamo la sensazione di non usare la matematica, che quindi rimane percepita esclusivamente come astratta. Sarebbe molto più semplice apprendere la matematica se ricordassimo, per esempio, che il Teorema di Pitagora nasce in un momento e da un problema preciso, dal tentativo di risolvere la questione relativa alla diagonale del triangolo, che, in quanto incommensurabile, voleva che ci fossero altri numeri rispetto a quelli conosciuti, dal desiderio, insomma, di colmare un buco. La matematica tende a completare tutto, è questa la questione: come un blob astratto, deve andare a riempire i buchi che individua inventando altri spazi. È una disciplina che non ammette di essere slabbrata.
Esatto. Non a caso prima facevo un riferimento alla grammatica, definendola astratta al pari della matematica. Proprio in virtù di questa loro astrattezza, queste discipline non ammettono una dimensione morale e l’errore è per forza un contributo.
Questo è vero, ma vorrei aggiungere qualcosa. Il matematico De Finetti esprime in merito all’errore delle parole con cui non si può non essere d’accordo: l’errore, dice De Finetti, non è contestabile; deve necessariamente essere considerato come un processo conoscitivo, perché l’errore “sei tu”; non ammettere l’errore significherebbe negare che l’io possa conoscere. Quando lessi per la prima volta le parole di De Finetti in merito all’errore avevo vent’anni ed ebbi subito la sensazione che dicessero qualcosa che riguardava me, che riguardava tutti. Tuttavia, non ero pronta ad ammettere che io ero l’errore di valutazione delle cose: non riuscivo a prendere l’errore su di me.
Anche quello dell’insegnante è un punto di vista parziale, sì. Sicuramente è il punto di vista di una persona che ne sa di più rispetto a chi ha di fronte – altrimenti non sarebbe lì. Tuttavia, bisognerebbe liberarsi dell’idea che spesso massacra lo stesso insegnante, ovvero che il sapere di più equivalga all’avere ragione. Ciò non è affatto vero, evidentemente, perché anche il tuo sapere di più è affetto da errore, un errore che sei tu. Sotto questo aspetto la matematica è fantastica, perché se da un lato dice che in qualunque processo c’è un errore che dipende da – ed è correlato a – un punto di vista, dall’altra afferma anche che quell’errore si può minimizzare: in pratica, non si può fare a meno di sbagliare, ma si può sapere quanto si sta sbagliando. Ciò avviene quando si fa matematica molto avanzata, ma anche nei ragionamenti, per così dire, più umani, quando, pur non sapendo tutto di qualcosa, si sa abbastanza per proseguire un ragionamento. Se si accetta l’idea che le conoscenze siano abbastanza e non siano tutte, che possano essere integrate, allora anche la didattica può trasformarsi in un dialogo tra chi insegna e chi apprende: se i processi sono in itinere, se i discorsi sono parziali, se tutto può essere aggiornato o migliorato, allora tra chi insegna e chi apprende, piuttosto che un passaggio di conoscenze dall’uno all’altro, si instaura la possibilità di un dialogo verso una soluzione, la costruzione di un percorso insieme.
Sarò sincera: ero convinta che l’uscita di questo libro mi avrebbe attirato lo sdegno e lo scherno della comunità scientifica, ma le cose non sono affatto andate così. Al contrario, ho avuto la sensazione di aver aperto un vaso di Pandora e che il mio punto di vista fosse condiviso da moltissimi matematici, convinti, come me, che, più che verità assolute, quello che di cui disponiamo e che possiamo insegnare è un linguaggio, che, in quanto tale, è affetto da molti errori. I concetti che abbiamo e che possiamo passare non sono verità religiose, non sono salvifici in sé: sono utili e si possono imparare per un’utilità. Per come vengono presentati a scuola, i processi matematici non sono passibili di approssimazione, non sai a che punto della storia umana arrivano: sembra che siano lì da sempre. Ecco, forse basterebbe semplicemente cominciare a dire che un concetto non c’è da sempre, ma è stato introdotto, per esempio, nel 1840; che, per riprendere quanto dicevi prima, un concetto non c’è da sempre, ma è stato sviluppato quando Leibniz si è inventato il calcolo differenziale, che ha elaborato perché era ossessionato dalle monadi e aveva bisogno di un linguaggio per parlare di queste cose che non avevano porte e finestre, che erano indivisibili. Se la matematica venisse insegnata in modo più storicizzato, sembrerebbe più umana e, come tutte le cose umane, non sarebbe strano considerarla affetta da errore.
Una volta fatto questo passaggio, la matematica ti si mostra nel suo carattere analogico e non filologico: diversamente dalla letteratura, in cui, per esempio, una poesia ha una forma e non potrebbe averne un’altra, in matematica si gioca con le relazioni, per cui, una volta fissati dei cardini, nel mezzo ci fai il disegno che vuoi. Adesso forse non si potrebbe più fare questo esempio, perché è un gioco che non usa più, ma quando insegnavo era un’immagine cui ricorrevo spesso e che i ragazzi capivano al volo: quando ero piccola, c’era un gioco fatto di tavole bucate e chiodini con cui potevi comporre la figura che volevi; io, a volte, fissavo i chiodini e poi li univo con i fili di cotone, andando a comporre disegni sempre diversi. La matematica è questo: fissati i chiodini, ognuno può fare il disegno che vuole, purché li tocchi tutti.
Esatto! È proprio questa la cosa divertente. La matematica è una disciplina analogica, che non solo non è filologica, ma non ammette neppure filologia: ognuno può dimostrare il teorema o fare l’equazione come vuole. E in questo è il suo essere profondamente umana: noi esseri umani siamo analogici, pensiamo per analogie. Il nostro cervello più vecchio dal punto di vista neurologico è un cervello analogico, che è più complesso, ma più veloce. Dunque, la matematica ha molto a che fare anche con il modo in cui noi pensiamo. Non è altro che un metodo conoscitivo, esattamente come il disegno.
Se la matematica, oltre a essere pensata come disciplina storicizzata, venisse considerata più di metodo che di merito, perderebbe quel carattere angoscioso tipico di una materia per la quale solo alcuni possono essere portati.

(Scauri,1978) Ha scritto romanzi, racconti, critica letteraria e teatro. Il suo ultimo libro è La matematica è politica, Einaudi, 2020. Redattore di Nuovi Argomenti, collabora con L’Espresso, Domani giornale e Vanity Fair. Su Rai Radio 3 conduce, ogni domenica mattina, il programma L’isola deserta e con Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini cura Ad alta voce. Per nottetempo, ha tradotto e curato Flush, Freshwater e Tra un atto e l’altro e di Virginia Woolf, e con Alessandro Giammei, il carteggio, Woolf-Stratchey. È la responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsilio. Ha un dottorato in Calcolo delle probabilità.