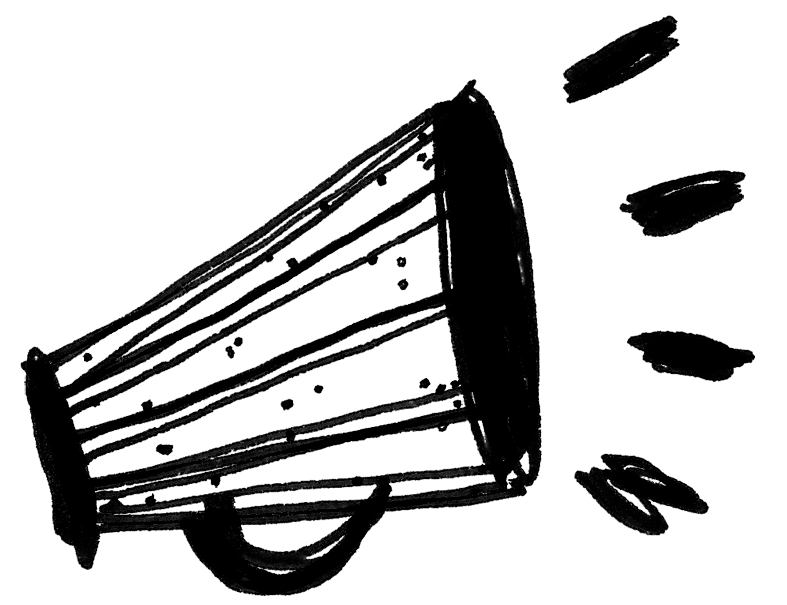Alla scoperta dell’e-lit
Intervista a Roberta Iadevaia

Roberta Iadevaia, giornalista ed esperta di media elettronici, è l’autrice di Per una storia della letteratura elettronica italiana, il primo libro che si pone come obiettivo quello di ricostruire la traiettoria storica della letteratura elettronica italiana. Un fenomeno a cui si possono ricondurre diversi generi (dalle opere multimediali interattive alle storie che si sviluppano a cavallo tra realtà fisica e virtuale), accomunati “dall’utilizzo creativo dei media digitali”. Una storia, quella della letteratura elettronica, che ha radici ben più profonde di quanto si potrebbe pensare a prima vista. Per questo abbiamo contattato Roberta e le abbiamo fatto qualche domanda a proposito del suo lavoro.
Partiamo dalle basi, che cos’è la letteratura elettronica?
Non esiste una definizione univoca, né universalmente accettata di letteratura elettronica (o e-lit, abbreviazione inglese molto diffusa), così come non esiste ancora un canone.
Potremmo definire la e-lit una forma d’arte letteraria che sperimenta col linguaggio dei media digitali. In queste opere il digitale non entra (solo) come tematica, ma come strumento – per la realizzazione e la fruizione – e come modello estetico. Infatti, anche quando un’opera fuoriesce dal medium informatico (ad esempio la stampa di uno dei risultati di un generatore automatico di testo), il modello di riferimento non è più l’interfaccia culturale libro, ma il computer. Si dice che le opere di e-lit incarnano l’estetica del digitale appunto perché si avvalgono di una scrittura formalizzata: l’informazione è quantizzata in unità discrete, finite, esatte, certe, indivisibili e limitate. Tuttavia, a differenza dell’informatica tout court, il digitale non è utilizzato in modo funzionale, ma in modo poetico, altro (ed è per questo che parliamo di letteratura). La letteratura elettronica si avvale certamente di una scrittura a vincoli, ma questi vincoli non sono considerati dei limiti; al contrario, rappresentano uno stimolo alla creatività, sulla scia dei “maghi bambini” dell’Oulipo e delle loro bizzarre creature nate dall’incontro tra matematica e letteratura. Abbiamo così: generatori che producono testi sempre diversi, storie multilineari in cui chi legge ha più o meno libertà di movimento (come i librigame, le avventure testuali, i MUD, la Hypertext Fiction e alcuni videogiochi), testi accessibili solo in una determinata fascia oraria o in un determinato luogo (come la seconda sezione della raccolta “Poesie elettroniche” di Fabrizio Venerandi). Ma questi sono solo alcuni esempi di generi riconducibili alla letteratura elettronica.
A questo punto credo siano già emerse alcune delle motivazioni che possono spingere chi scrive ad abbandonare l’interfaccia libro e a rivolgersi a quella elettronico-digitale: manipolare la linearità, utilizzare più codici simultaneamente (opere multimediali), vincere la staticità del testo in sé (poesie animate, generatori) e quella del processo di fruizione (opere interattive), esplorare nuovi spazi dello scrivere (i commenti in un codice sorgente, i livelli in un’opera in realtà aumentata e, più in generale, i “ponti” tra realtà fisica e virtuale). Se le modalità dipendono dalle singole intenzioni artistiche, alla base delle sperimentazioni elettronico-letterarie possiamo individuare il desiderio/necessità di utilizzare il linguaggio dei media digitali in modo alternativo rispetto al modello dominante e riflettere sulle mutazioni cognitive determinate dai media digitali stessi.
Credo che questo sia un aspetto fondamentale che va sottolineato: chi sceglie di scrivere in questo modo non intende esaltare acriticamente la tecnologia; al contrario, è proprio in virtù del malessere generato da e attraverso la tecnologia che chi scrive si propone di rimodellare e trasformare la stessa tecnologia in uno strumento dell’immaginazione.
Da questo punto di vista, come ha osservato Massimo Riva, la letteratura elettronica può essere considerata come l’esecuzione compiuta del genere cyberpunk in quanto consente a chi legge di sperimentare in concreto quello che le metafore letterarie possono solo permettere di immaginare: una nuova logica post-umana o non-umana che si traduce in un’immaginazione non più esclusivamente linguistica, ma anche algoritmica. Sono appunto queste logiche e questi linguaggi diversi a essere messi alla prova dalla e-lit che, così facendo, mette in risalto le possibilità, ma anche i rischi e i limiti, dell’interazione tra agenti umani e non-umani.
La letteratura elettronica appare quindi fondamentale soprattutto in un contesto come quello contemporaneo in quanto, citando nuovamente Riva, si propone una sfida duplice: riprogrammare il testo attraverso le possibilità aperte dal dispositivo informatico e ripensare le possibilità del medium attraverso i codici del letterario.
Al centro del discorso non c’è la tecnologia in sé, ma l’innesco di nuove relazioni, nuovi modi di raccontare il mondo e nuovi paradigmi per riscriverlo, che tengano conto delle implicazioni sociali, politiche, economiche, culturali, letterarie e artistiche della tecnologia, nel rispetto dei (bi)sogni dell’essere (post)umano. C’è una frase del poeta e fisico francese Philppe Bootz che credo sintetizzi bene tutto questo: chi scrive affronta un incessante combattimento contro la macchina e la sua condizione. Ecco, credo che una delle cose più affascinanti della letteratura elettronica sia che ci spinge a chiederci, di fronte a una frase come questa, a quale macchina ci si sta riferendo.
Restiamo su quest’ultimo punto, nell’introduzione del libro distingui tra un “testo di superficie” e un “testo sorgente”. Dove il primo è immediatamente visibile e accessibile alle persone, mentre il secondo, che è il codice, è celato e non è detto che sia immediatamente comprensibile a chi fruisce un’opera di letteratura elettronica. Ti va di approfondire qual è la relazione tra uomo e macchina che si struttura in questo genere letterario?
Permettimi di precisare che la e-lit non è un genere, ma un fenomeno che comprende diversi generi. In secondo luogo, la compresenza di (almeno) due livelli è una prerogativa di tutto ciò che è elettronico digitale: i siti web che consultiamo, ad esempio, non sono che la traduzione, effettuata dai browser, di un testo “sottostante” contenente del codice (per accorgersene basta ispezionare la “sorgente pagina”, appunto).
La differenza fondamentale tra le applicazioni informatiche “comuni” e l’arte digitale risiede nel rapporto tra questi due livelli: le prime tendono a nascondere il livello del codice (il testo sorgente e i processi che innesca) dietro un’interfaccia pulita, brillante, rassicurante, standardizzata, facilitata; la seconda, al contrario, evidenzia il codice sottostante portandolo in superficie, generalmente rendendo il testo di superficie difficile da leggere e quindi da gestire e controllare. Per avere un’idea basta confrontare la homepage di Google con quella del sito del celebre duo di net artisti jodi: la prima appare trasparente e solida, la seconda, al contrario, sembra opaca e “rotta”, caotica e poco sicura.
Attraverso il perturbante e lo straniamento chi fa arte intende dimostrare l’irriducibilità dell’essere umano alla macchina. Questo non vuol dire sostenere che l’essere umano non sia una macchina o sia del tutto separato dalla tecnologia. Al contrario, la e-lit si fonda sulla consapevolezza che l’essere umano sia un cyborg, un soggetto ormai postumano che si riprogramma continuamente interagendo con la macchina, così adotta un linguaggio ibrido, alternativo sia all’organico-naturale che all’inorganico-artificiale.
La relazione tra umani e macchine a cui ti riferivi rappresenta il nucleo della letteratura elettronica, sia dal punto di vista formale che simbolico.
Io considero l’approccio degli scrittori elettronici affine a quello degli umoristi neri: poiché un ritorno a una condizione pre-rivoluzione digitale sarebbe impossibile, non resta che appropriarsi dei linguaggi e delle logiche delle forze dominanti, portandoli però alle estreme conseguenze in modo da palesarne l’insostenibilità. Chi scrive si diverte a dimostrare che l’essere umano è una macchina che funziona fin troppo bene quando accetta di barattare la propria agency, ovvero le sue capacità di lettura e scrittura, di intervento, in cambio di un’esperienza (di vita) placida, comoda, ottimizzata, passiva e controllata.
La e-lit può essere considerata un continuo tentativo di spostare l’asticella sempre più verso la componente umana rispetto a quella macchinica, per mostrare che l’essere umano è una macchina che funziona male perché non è mosso dalla sola logica. Non vuol dire che, per essere umani, si debba essere per forza disfunzionali: la critica della e-lit è un invito a immaginare e realizzare nuove funzionalità più eque e rispettose dell’ecosistema di cui fa parte, anche, l’essere umano.
Dalle tue parole ci si potrebbe fare l’idea che questo sia un fenomeno piuttosto recente. Leggendo il tuo libro si scopre invece che ha radici molto profonde, che si spingono anche molto prima che i computer fossero inventati. Puoi farci una breve periodizzazione?
Nel libro propongo una prospettiva solo apparentemente paradossale, basata sul presupposto che sia possibile scrivere in modo “elettronico” anche senza utilizzare dispositivi elettronici. L’essere umano non ha aspettato l’avvento del computer per cercare di capire “come si smonta e come si rimonta la più complicata e la più imprevedibile di tutte le sue macchine: il linguaggio”, citando Calvino. Pensiamo alla poesia visiva, in cui il significato è reso non solo dalle parole, ma anche dalle immagini che queste formano disponendosi nello spazio. Parliamo quindi di un tipo di scrittura già multimediale e “animata” le cui origini risalgono addirittura al IV-III secolo a.C. (i technopaegnia). Un altro esempio è rappresentato dall’ars combinatoria: dagli eclatanti esperimenti condotti da Caramuel già nel 1663 (dalle poesie che si potevano leggere in più di un senso a quelle che potevano essere proiettate nella terza dimensione) fino ad arrivare all’Oulipo con le sue iper-poesie (un esempio su tutti: Cent mille milliards de poèmes realizzata da Queneau nel 1961) e i suoi iper-romanzi (un esempio su tutti: Il Castello dei destini incrociati di Calvino). Potremmo aggiungerne molti altri, effettivamente realizzati – come il Tristram Shandy di Sterne (1760) e Un coup de dés jamais n’abolira le hasard di Mallarmé (1897) – o soltanto immaginati, come la celebre macchina usata dai filosofi laputiani descritta da Swift ne I viaggi di Gulliver (1726). Dove il linguaggio è inteso come macchina combinatoria e lo spazio dello scrivere gioca con i limiti imposti dalla forma-libro, allora possiamo parlare, in senso lato, di “letteratura elettronica”.
Per finire, chi sono stati, a tuo parere, i più brillanti interpreti italiani di questo tentativo di far emergere la componente umana rispetto a quella macchinica attraverso la manipolazione elettronica del linguaggio? E quale opera consiglieresti a una persona che vorrebbe iniziare a immergersi in questo fenomeno?
Personalmente adoro [epidemiC] e Molleindustria: l’approccio low-tech, l’umorismo brillante e dissacrante, la complessa semplicità delle loro opere, la capacità di coinvolgere la community sono alcuni dei fattori che rendono queste due realtà un punto di riferimento non solo in Italia. Naturalmente la letteratura elettronica italiana può vantare numerosi altri esponenti, ma per questi vi rimando al libro. Vorrei precisare che il libro non ha pretese esaustive, ma vuole essere la prima mappatura di un fenomeno che, in Italia, è ancora poco conosciuto. Molti sono gli autori e le autrici ancora da scoprire, molti gli argomenti da approfondire. Se posso vorrei approfittare di questa intervista per inviare chiunque fosse interessato a contribuire alla ricerca sulla letteratura elettronica a prendere parte a LEI – Letteratura Elettronica Italia, il primo laboratorio permanente dedicato alla e-lit. Per rispondere alla tua ultima domanda consiglierei le poesie di Roberto Gilli e Daniela Calisi , Ergon/Logos di Molleindustria e la già citata raccolta Poesie elettroniche di Venerandi.
Roberta Iadevaia (Maddaloni 1988). Giornalista pubblicista, nel 2020 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Visual and Media Studies presso lo IULM di Milano. Nel 2021 ha pubblicato per Mimesis il saggio Per una storia della letteratura elettronica italiana. Nel 2014 ha co-curato il Festival internazionale della letteratura elettronica OLE.01. I suoi saggi sulla letteratura elettronica sono stati inclusi in pubblicazioni italiane (Questioni di intertestualità: arte, letteratura, cinema, Mimesis 2018; Testi brevi di accompagnamento. Linguistica, semiotica, traduzione, Universitas Studiorum 2019) e internazionali (Transmedia Literacy. From Storytelling to Interactivity in the Era of Distributed Authorship, Barcelona, Digital Culture Research Programme 2013; MATLIT: Materialidades de Literatura, Estudos Literários Digitalis 2018). Dal 2013 è membro della Electronic Literature Organization.