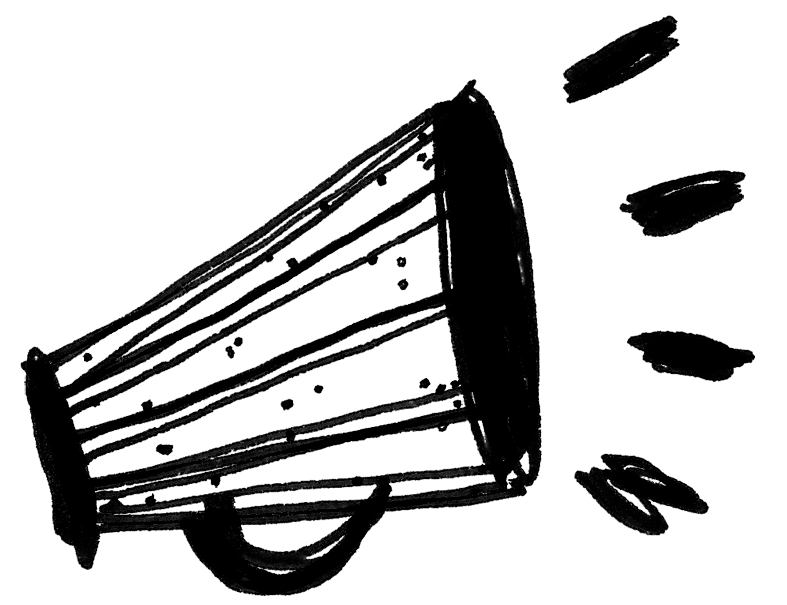Casa valigia
Intervista a James Bradbourne
James Bradburne, direttore generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense, ci racconta come un museo possa essere davvero la Grande Casa di tutti, capace di accogliere ogni persona che di esso senta il bisogno e di mostrare il piacere di imparare.
Quale dovrebbe essere, secondo lei, il rapporto tra bambini e museo? Come lo concepisce?
Vorrei cominciare dicendo quale dovrebbe essere, innanzitutto, il nostro rapporto con i bambini, perché spesso è questo il punto più problematico.
Ecco, io credo che il rapporto con il bambino debba essere improntato sul rispetto. Il bambino, come si è più volte detto a Reggio Emilia, di fatto non esiste: l’età non è una caratteristica fissa, ma relazionale. Lei è più giovane di me e probabilmente mi considera anziano, ma io non mi ritengo tale se mi penso paragonato al mio amico di ottantasette anni. Allo stesso modo noi definiamo bambini coloro che sono più giovani di noi, ma la loro età non ha valore al di fuori di questa relazione.
Il bambino è una persona esattamente come noi, con tutti i diritti, con tutte le libertà e, soprattutto, con la sua autonomia, che dobbiamo imporci di rispettare. Certo, è un essere umano che ha fatto meno esperienza, che ha sperimentato meno rischi e, per questo, abbiamo il dovere di proteggerlo, ma ciò non equivale a considerarlo una mini-persona o una piccola persona: è una persona. La cosa principale da comprendere prima ancora che un bambino varchi la soglia di un museo o anche di una scuola è che l’età non è una categoria affidabile per immaginare ed elaborare un programma. Piuttosto, è utile tenere conto delle fasi di sviluppo e dell’esperienza e, in virtù di queste, creare molte e varie proposte. Dobbiamo immaginare un’esperienza museale adatta a ogni livello di preparazione, diverso a seconda delle fasi della vita. È evidente che a un bambino di due anni non possiamo rivolgerci come lo faremmo con un dottorando, ma è anche vero che i bambini di sette anni possono vantare una formazione e una preparazione che manca agli adulti di venticinque anni. Non si tratta, dunque, di stabilire una gerarchia di preparazione, quanto di rispettare le differenze che ci sono.
Un bambino che entra in un museo è una persona che va rispettata totalmente. Una parte fondamentale del rispetto è l’ascolto. Il museo è un luogo in cui non deve dispensarsi la verità, ma dove abbiamo il dovere di ascoltare, ovvero tollerare, immaginare che ci siano diverse possibilità e opinioni, diversi punti di vista. Una volta preso questo come punto di partenza, possiamo finalmente cominciare a elaborare proposte declinate per le diverse preparazioni, soprattutto per quelle tipiche dei più giovani come i bambini.
Nei primi quindici anni di vita la preparazione cambia molto velocemente: la differenza tra un bambino di due anni e uno di quattro è enorme, ma è del tutto comprensibile, visto che il secondo ha vissuto il doppio rispetto al primo. L’offerta museale deve tenere conto di un cambio così rapido, riconoscendo che ciò che interessa a un bimbo di quattro anni non appassiona allo stesso modo chi ne ha otto; così come non si può pensare di coinvolgere con la medesima offerta un adolescente, che per definizione non si ritiene più un bambino e, al contempo, ha un rifiuto nei confronti dell’adulto. Gli adolescenti sono il pubblico più difficile per un museo, ma io non credo che si dovrebbe insistere affinché ci vengano (anche se spesso i musei, soprattutto oggi, sembrano essere ossessionati dall’idea di attirare i ragazzi di quell’età). L’adolescenza è il momento in cui differenziarsi, sperimentare e non mi spaventa non vedere un sedicenne in un museo, se è lui a non voler venire. Non credo spetti a noi convincerli a farlo.
Penso, piuttosto, che il nostro lavoro inizi prima, facendo in modo che un bambino di due, quattro, sei anni che visiti il museo con la famiglia o con la classe possa farne un’esperienza positiva e scoprirvi cose capaci di aprirlo a diverse possibilità per la sua vita. Ricordo che un giorno, durante un’intervista, mi trovavo di fronte a un quadro di Carpaccio con uno storico dell’arte molto noto e competente e stavamo discutendo di quanto quel quadro in effetti, per tutte le dovute ragioni, non fosse un granché; bene, lui mi confessò che quando aveva otto anni proprio quell’opera era la ragione che lo portava a tornare in museo ogni weekend e il motivo era molto semplice: il coniglio dipinto sotto la sedia. L’aveva scoperto o gli era stato indicato quando era piccolo in occasione della sua prima visita al museo, che, da quel momento, in virtù dell’emozione che aveva provato, era diventato per lui come una casa. Ecco, il nostro lavoro si basa su questo tipo di esperienze: se lavoriamo bene, il museo diventa una Grande Casa dove si va con piacere.
Non è nostro compito costringere le persone a venire nel museo, ma un museo dovrebbe essere pronto ad accogliere tutti coloro che ne sentono il bisogno, sia questo dovuto a curiosità, alla ricerca di ispirazione o di consolazione. Le persone possono aver bisogno di un museo, come hanno bisogno di un ospedale o di una scuola ed è per questo che è giusto che anche i musei siano, come in effetti sono, classificati come servizio essenziale. Dobbiamo essere in grado di corrispondere alle attese di chi ha bisogno del nostro servizio. E, vista l’eterogeneità del nostro pubblico, dobbiamo creare un ambiente ricco di diverse opportunità, che consentano a ciascuno di scoprirsi attraverso il nostro patrimonio, ovvero le tracce lasciate da altre persone. Non tutti, ovviamente, frequentando il museo diventeranno storici dell’arte: emozionarsi nel vedere un coniglio dipinto in un quadro di Carpaccio potrebbe essere l’esperienza chiave nella vita di un futuro biologo e, se questo accade, tanto meglio! Il punto è che il museo sappia essere un luogo in cui nascono passioni per la vita.
È proprio questo il senso che do a un’affermazione come “il bambino non esiste”. Per me tutti meritano il medesimo rispetto, che si tratti del nuovo arrivato dalla Siria, del marchese milanese o di un bambino. Ciò che importa è che il museo sappia essere la Grande Casa disponibile e preparata ad accogliere la “persona” quando ne ha bisogno.
“In museo ciascuno potrebbe trovare una parte della sua identità, ma anche condividerla. Potremmo cioè andare insieme io, un immigrato appena arrivato dall’Africa e un marchese milanese da mille anni e creare una narrazione data dalla nostra esperienza attorno a Caravaggio: tutte valide, è il nostro Caravaggio. Costruiamo la nostra cittadinanza anche attorno a Caravaggio, vivendo insieme a Milano attorno alla nostra casa collettiva; la nostra grande casa, Brera” M.C.Ciaccheri, A.C.Cimoli, N.Moolhuijsen, Senza Titolo, Nomosedizioni, 2020, p.98.
Mi sembra che quanto afferma qui, possa essere esteso anche nei confronti del bambino: in un museo ogni punto di vista merita la stessa attenzione ed è importante quanto quello di uno storico dell’arte?
Vorrei sottolineare un aspetto importante, soprattutto visto che è “Politica” il nostro tema di riferimento. È vero, io vorrei che ogni persona che arriva in museo e scopre Caravaggio possa farlo suo, ma è altrettanto vero che Milano è una città cosmopolita, in cui ormai vivono grandi comunità – come quella coreana, russa o siriana, solo per citarne alcune – che non sono rappresentate nei nostri musei ed è normale e giusto che queste persone si chiedano la ragione di questa assenza. È lo stesso interrogativo che solleva un movimento come Black Lives Matter: «perché non ci siamo anche noi in quella che dovrebbe essere la casa di tutti?», «perché la nostra grande casa ha scelto le cose che appartengono solo a un piccolo gruppetto?». Nell’Ottocento avremmo potuto dire che quello contenuto a Brera è un patrimonio che parlava di tutti, ma oggi la demografia è cambiata e abbiamo il dovere di chiederci questo: come possiamo creare una struttura museale in cui anche altre persone, altri cittadini di diverse origini e religioni, provenienti da altre parti del mondo, possano sentirsi a casa?
Una possibile soluzione è quella di passare dall’idea del visitatore a quella di socio o tesserato. In qualità di visitatore io compro un biglietto che mi fa accedere a spazi che appartengono a qualcun altro, ma quando acquisto una tessera associativa divento un membro, ovvero una parte integrante della comunità museale che ha il diritto di essere ascoltato e che il museo ha il dovere di ascoltare. Una simile comunità saprebbe rispecchiare il cambio demografico in atto nel corso degli anni e le sue istanze sarebbero prese in considerazione dalla direzione del museo. Perciò, potrebbe accadere, per esempio, che la crescente popolazione coreana faccia sentire la sua voce chiedendo come mai nella Grande Casa milanese non sia presente un capolavoro della loro arte. La questione non si risolve auspicando l’arrivo di un direttore illuminato, ma lasciando che la comunità abbia una voce nel consiglio.
Diventare la Grande Casa di tutti e non soltanto di pochi: questa è la prossima sfida che ci attende. Credo che sia necessario un cambio sistemico e non individuale: è la struttura che dovrebbe permettere lo spazio per voci che devono essere ascoltate. Voci obbligatorie, pur non essendo vincolanti, perché non si vuole annullare il ruolo degli esperti e della direzione, che rimane fondamentale. Tuttavia, un ascolto obbligatorio non vincolato sarebbe un passo enorme per coinvolgere la città nel suo complesso.
Tutto questo discorso può essere fatto anche per i bambini, che hanno esattamente lo stesso diritto a essere ascoltati. Ho tenuto una conferenza stampa in occasione dell’uscita del mio ultimo libro (il terzo della trilogia su Brera che ho scritto proprio pensando ai bambini), che si intitola “I fantasmi di Brera”: erano presenti molti bambini, cui è stata data la possibilità di fare delle domande e che si sono rivelati estremamente preparati, desiderosi di capire. Di fronte a domande come «Dove sono i fantasmi?», «Come possono uscire?», «Come fanno a entrare quando la biblioteca è chiusa?» non sarebbe stato giusto limitarsi a sorridere, perché erano questioni interessanti che riflettevano sulla proposta narrativa del libro che ho scritto e io, come autore, ho ascoltato con molto rispetto e con molta attenzione.
Come ha detto Franco Russoli, un museo è il luogo della cittadinanza, dell’identità. Chi siamo è determinato da ciò che insieme abbiamo deciso di portare con noi nel futuro. Ho lavorato per qualche anno in un museo di Francoforte, dove è molto alta la percentuale di cittadini turchi arrivati in Germania negli anni Cinquanta come Gastarbeiter e che tuttora vi risiedono con le loro famiglie. Nel programma che ho elaborato allora per il museo in cui lavoravo ho tenuto conto di questo dato: lasciavo il museo aperto fino alle 20 di modo che potessero venire; ho fatto in modo che tutte le didascalie fossero scritte anche in arabo e in turco; ho previsto una proposta che invitava i bambini a intervistare i loro nonni per sapere che cosa si fossero portati in Germania dalla Turchia, che cosa avessero messo nella loro valigia: il più delle volte i racconti rivelavano che non si trattava di oggetti di valore monetario, ma preziosi in virtù di un legame affettivo, storico, tradizionale o personale. Quando abbiamo un museo siamo tutti emigranti: lo siamo nei confronti di un futuro incerto, che siamo noi stessi a creare. E che cosa portiamo con noi? Il museo è uno dei luoghi più importanti in cui facciamo le nostre valigie: portiamo con noi Caravaggio, Bellini, Boccioni. Ce li portiamo perché ci aiutino, ci ispirino, ci consolino. Ecco perché è imprescindibile che, quando la demografia e la città mutano il loro colore, il museo sappia rispondere a questo cambiamento, riflettendo così le anime e le esperienze di tutta la comunità.
L’ascolto di cui parla è un ascolto che si traduce in azioni molto pratiche e semplici, ma decisive. Poco prima dell’inizio del lockdown sono venuta a Brera con le mie figlie e ho sperimentato esattamente ciò che ci sta raccontando: ho trovato un ambiente molto accogliente, ricco di piccole accortezze estremamente significative, come la borsetta con il blocco da disegno e le matite colorate, le sedute davanti ai dipinti dove si poteva sostare e disegnare o le didascalie. Abbiamo passato 4 ore piacevolissime all’interno del museo seguendo l’attenzione e la volontà delle bambine. A sottolineare che attenzioni piccole, semplici e pratiche rendono l’ascolto non retorico o astratto, ma autentico e incarnato.
È l’”ascolto visibile”: ascoltare non è abbastanza e dobbiamo mostrare quanto abbiamo ascoltato. È una scuola di pensiero, una filosofia ispirato all’approccio di Reggio Emilia, che ho fatto mia. Ho sperimentato la strategia della borsetta a Francoforte nel 2000 e già allora notai come le visite delle famiglie, che normalmente si interrompevano prima delle altre, durassero di più: la borsetta, che contiene attività adatte a diversi livelli di preparazione, alcune più semplici e altre più complicate, riusciva a coinvolgere i diversi membri di una famiglia, dal fratellino più piccolo a quello più grande, rendendo di conseguenza più serena e rilassata anche l’esperienza di visita dei genitori. Le famiglie, alla fine, rimanevano di più e questo è sensazionale. Per questo, una volta arrivato a Palazzo Strozzi, ho proposto anche lì il medesimo modello e la stessa cosa ho fatto giunto a Brera: e funziona ancora!
L’invito a disegnare, invece, suggerisce che nessuno dovrebbe vivere il museo come uno spettatore passivo, ma anche che gli artisti non sono nati artisti: prima di diventarlo sono cresciuti, hanno imparato, studiato e, dal momento che tutti possiamo avere un’opinione, cimentarci a scrivere una poesia o a disegnare un quadro, allora alcuni potrebbero anche divenire artisti. Tuttavia, come dicevo prima, se chi frequenta il museo alla fine non diviene un artista, ma un biologo o un ecologista o qualunque altra cosa, va benissimo: l’importante è che l’esperienza museale li aiuti a scoprire che è in loro potere gestire e dirigere la propria vita.
Questa è l’idea dell’autonomia, profondamente basata sul rispetto, da cui siamo partiti. È un’idea che adesso pervade Brera, ma che ne faceva già parte prima che arrivassi io: ad attendermi ho trovato il patrimonio valoriale lasciato dal grande direttore Wittgens, che parlava del museo vivente. Non ho dovuto lottare per affermare valori in cui credevo, perché questo posto era già ben preparato. E non posso dire lo stesso di tutti i musei. Io sono in linea con Brera, con i valori braidensi, che sono quelli della Rivoluzione Francese, dell’Illuminismo: valori radicali, attivisti, sociali, che credono nell’educazione popolare. Brera è nata durante la Rivoluzione Francese per volere del più giovane generale dell’esercito rivoluzionario: Napoleone è arrivato a Milano portando con sé le fresche, nuove e radicali idee di un museo che, come il Louvre (aperto solo quattro anni prima), fosse anche un istituto dedicato all’educazione popolare, ai giovani artisti contemporanei e sapesse dialogare con il pubblico. Sono questi i valori braidensi, che sono per me una continua ispirazione e che spero di riuscire a portare avanti.
Il racconto che ci ha fatto come si declina nella visita di un bambino che non arriva nel museo con la sua famiglia, ma con la sua classe? Sono esperienze diverse e quella vissuta con la scuola è caratterizzata da una rigidità maggiore.
La scuola è un sistema formale. E devo dire che io amo lavorare nel museo proprio perché sono convinto del valore dell’apprendimento informale, ovvero fuori dalla scuola. Credo che il museo sia un luogo molto sovversivo, dove può manifestarsi l’autonomia, l’autogestione e il totale rispetto dei bambini. Spesso, purtroppo, a scuola accade il contrario e ha la meglio un modello di istruzione che guarda il bambino dall’alto in basso. Si può dire che, rispetto al mondo scolastico, che per fortuna la mia squadra didattica conosce e con cui riesce a dialogare molto meglio di me, io ho proposto un contro-mondo: una bolla di libertà in cui mi auguro che i bambini riescano a capire che imparare è un piacere, un soffio d’aria fresca.
Nel museo possiamo imparare quanto la vita di chi esplora ed è curioso sia piacevole. E, se ci pensiamo, il piacere, anche dal punto di vista evolutivo, è connesso a ogni attività fondamentale. Le specie animali che non hanno trovato piacere nell’accoppiamento si sono estinte, mentre si sono moltiplicate quelle che nel riprodursi hanno trovato piacere. Quanto all’apprendimento, possiamo fare un discorso simile, perché gli esseri umani che non hanno avuto la curiosità di domandarsi che cosa fosse stato a provocare quel rumore sospetto nel bosco sono stati con molta probabilità uccisi da quella minaccia.
La curiosità fa parte del nostro DNA e il piacere di imparare è ovvio e forte: è un vero piacere, non possiamo negarlo. E questo è l’obiettivo che un museo dovrebbe sempre prefiggersi: essere in grado di mostrare che imparare è un piacere.