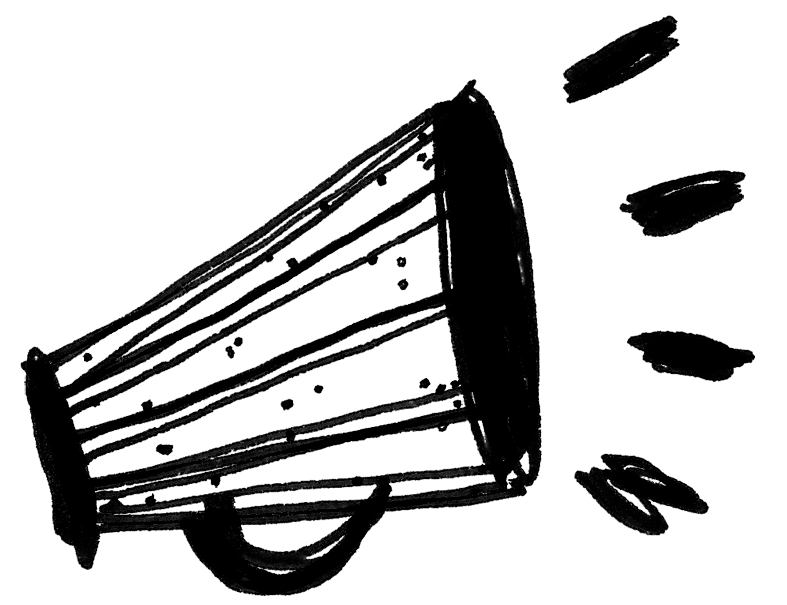ossia su “la consapevolezza pura e semplice: la consapevolezza di ciò che è così reale e essenziale, così nascosto in bella vista sotto gli occhi di tutti da costringerci a ricordare di continuo a noi stessi: Questa è l’acqua.” –
A cura di Giuseppe Russo Rossi
Viviamo in un momento storico in cui, a quanto pare, la dimensione artistica viene privata della sua risorsa salvifica.
È un punto di vista. Ma molto diverso dal mio.
Credo che l’arte, sia essa fruita o praticata, sia un sollievo e un conforto, al pari di una medicina. Credo, anche a motivo della mia esperienza personale e familiare, che in molte occasioni l’incontro con una melodia, una pagina scritta o un foglio bianco da riempire, una tela immacolata o un’immagine dipinta possa salvare una vita. Forse non sul piano fisico, d’accordo, ma senz’altro su quello spirituale. Credo che poter imparare qualcosa, sia esso una nozione pratica, il formarsi e l’articolarsi di un pensiero o il sentir nascere una nuova emozione, sia sempre una forma di salvezza, che, nel caso dell’arte, si realizza come un incontro casuale ma fatale. Credo che, ad esempio, un’opera come l’Iliade, sia stata una sorta di per i contemporanei di Omero. Eppure quando un autore scrive racconti, romanzi o poesie, il più delle volte non vuole insegnare nulla. È alla sua esperienza che pensa quando getta le parole sulla carta, ma, nonostante questo, può capitare che quelle righe ci sembrino scritte apposta per noi, per rispondere alle domande che in quel momento ci assillano o ai dubbi che ci sfiorano. In più, pensare che molte altre persone altrove stanno facendo contemporaneamente un’esperienza simile rivela una corrispondenza che non può che darci sollievo. Per questo l’arte ci salva, perché , che sa colorare, scuotere e rinvigorire l’esistenza umana, proprio come un sorso d’acqua può restituire forza e fiducia a un corpo stanco.
1.
Specchio d’acqua

Che colore ha l’acqua? Riflette e rappresenta le tonalità del cielo. Grazie a questa mimesi naturale le nostre inquietudini si acquietano. Lo sforzo razionale, meno spontaneo, di valutare la fattiva trasparenza delle masse d’acqua è una banalità. Quali colori riuscite a vedere nell’udire le parole: Che cosa vi suggerisce la vostra immaginazione? Senza che possiate rendervene conto, il vostro pensiero correrà verso la sua propria interpretazione. L’interiorità, personale, sensibile e diversificata, verso cui la caratura umanistica impone tolleranza e comprensione, è sempre il termine di paragone imprescindibile. Eppure, laddove il risultato sarà per tutti differente, l’esperienza poetica avrà valore universale: unire e fondere, tanto nell’astrarre quanto nell’immaginare, ciò che con occhi freddi e distaccati rischieremmo di disgregare. In ciò sta la proprietà salvifica dell’arte, specialmente se calata in un presente come il nostro.
Durante i miei corsi universitari, c’era un esame di letterature comparate sull’uso della figura retorica dell’ἔκϕρασις, ovvero . Questa raffinata abilità, di antichissima origine, era riportata a tematiche attualizzanti e, in fin dei conti, del tutto personali poiché riferite a chi “inventa”, chi descrive e rappresenta, in un’esaltante metafora antropomorfa del linguaggio ancestrale e primitivo, fatto di miti, favole e riti atavici, produttività di quella stessa umana immaginazione che direziona la qualità del nostro pensiero.
(Ugo Foscolo, Principj di critica poetica).
2.
Colori ad acqua
Ho passato due anni come volontario in un hospice per terminali oncologici. Inizialmente indossavo un camice bianco, conversavo e davo da mangiare ai pazienti, cercando di collaborare con lo staff medico per quanto fosse possibile. L’odore di scatole da laboratorio non mi disturbava e, tutto sommato, mi sentivo molto a mio agio nel palesare comprensione, ascolto e un pizzico di gentilezza in più rispetto al normale. In prossimità della morte la gente vuole parlare e raccontare il più possibile. Ricordo una bambina, dalla mente veloce; nonostante gli otto anni d’età, aveva una di quelle intelligenze pronte, vivaci ma magnificamente incentrate sugli aspetti emotivi dell’essere umani. O meglio, del restare umani. La aiutai a costruire un robottino progettato per l’apprendimento scolastico dei bambini con difficoltà motorie. Inutile dire che, alla fine, la più abile fu lei. Negli ultimi mesi decise di imparare a suonare il pianoforte e ci riuscì, tant’è che mi chiese spesso di suonare con lei. Io, inizialmente, non gradivo l’idea di trincerarmi dietro lo scudo protettivo della musica e preferivo di gran lunga “sporcarmi le mani”. Ma chiaramente cedetti alla richiesta. E fu una folgorazione. A quella bambina restava poco da vivere, francamente ne sembrava anche cosciente. La accompagnai suonando con lei nella Canzoncina della Bambola e in una Bourée di : non ho mai toccato con mano una così forte immedesimazione, mi aveva aperto la porta dei suoi sentimenti, in quel momento un tutt’uno con le note. Mi commossi sino all’angoscia, perché, senza spiegazioni esplicite, mi aveva comunicato tutto.
Un’altra volta mi ritrovai ad affrontare il ciclo delle sei Suites di Bach per i pazienti più adulti. Suonare Bach, per un musicista professionista, vuol dire . Ovviamente, per questi rendez-vous, si pensò ad un’impostazione non troppo canonica, in modo da consentire a chi ascoltava maggiore contatto e la possibilità di intervenire con le proprie riflessioni o pensieri o suggestioni, dettate dal momento. Un signore mi disse che, dopo l’ascolto, aveva avuto l’impressione di aprirsi come un passaggio attraverso un muro di ferro invisibile che gli sembrava trovarsi tra ciò che si sente e ciò che si può.
(Vincent Van Gogh)
3.
Fiumi di coscienza

Crescere in tempo di guerra è straziante, lo sappiamo tutti. Mio nonno non ha lavorato da artista, tuttavia nella sua vita ha recitato in vernacolo, ha suonato la fisarmonica, ha costruito modellini, ha incentivato mia madre e noi nipoti a studiare musica supportandoci economicamente e non ha mai nascosto la sua voglia di scrivere, scrivere, scrivere. Il 25 aprile 2020, festa della Liberazione d’Italia in isolamento Covid, io ho ritrovato alcune sue memorie, ricordandomi quella particolare consolazione affidata in maniera spontanea alla valenza delle parole. Certamente mio nonno non ha avuto occasione di frequentare grandi scuole né di leggere il monologo di Molly dall’Ulisse di ma, nonostante ciò, nei suoi testi ho ritrovato, per forma e per contenuti, la stessa , presentati così come affiorano nella mente: gli episodi si mescolano eludendo dall’ordine della punteggiatura, creando nel linguaggio stesso un , continuo, senza intralci, ininterrotto, che plasma elasticità nel ritmo, crea una materia uniforme a ritmi diversi. In questa poesia, sorgiva e polimorfa, il caos è foriero di rinascita, genuina nuova espressione di vita, avvalora l’esistenza contestualizzandola col supporto della memoria, :
“nel 1942 avevo otto anni e una cattiva fanciullezza i fascisti sequestravano me mia madre e le altre donne che come noi tornavano dai campi i soldati tedeschi sparavano a zig zag in direzione dei piedi a noi bambini se provavamo ad avvicinarci per chiedere un tozzo di pane che ci mangiavano in faccia seduti sulle panchine di pietra del Lungomare Nazario Sauro la vita doveva continuare e questo significava mangiare l’edificio scolastico Balilla di giorno era la mia scuola elementare e ad alta notte nei sotterranei diveniva il rifugio non appena suonavano gli allarmi per tutto il rione successivamente le aule furono tramutate in vere e proprie sale di ospedale in pochi giorni le brande si espansero nei lunghi e larghi corridoi accoglievano i soldati italiani feriti e portati lì con urgenza dai fronti dell’Albania della Grecia e del Giordano della Tunisia chi aveva perso le gambe o le braccia o le mani addirittura gli occhi soldati infettati di tifo febbre impidocchiati o con scabbia una carneficina tali ricordi sono rimasti come cicatrici nella mia vita io ero un ragazzo molto magro e leggero avevo l’agilità di arrampicarmi come uno scoiattolo pur di arrivare ad avere qualche galletta o qualche pagnotta che più delle volte si trovavano con la muffa i familiari che riuscivano a sapere che arrivavano i feriti dal fronte si prodigavano alle ricerche e alle notizie dei loro cari mamme mogli sorelle fidanzate nonni anziani con una certa età gente che arrivava dalla Puglia dalla Basilicata dalla Calabria portando uova salami formaggi le finestre erano molto alte e protette da reti ma io mi sapevo arrampicare bene così i familiari oltre alla roba che mi davano mi consegnavano dei biglietti scritti che scambiavo ai soldati feriti e tra una mano e l’altra fui contagiato di pidocchi e scabbia”
(Euripide, Elena)
4.
Sorgenti
Uno dei corsi più commoventi che abbia potuto seguire nel dipartimento di Italianistica fu quello di Dialettologia. Qualche volta il dialetto è vissuto come una sorta di onta ancestrale che una determinata popolazione si porta addosso. Si può tentare di nasconderlo, ma il più delle volte ci si scorda della ricchezza di identità che vi passa attraverso. Oltre ai contenuti ontologici, il dialetto assorbe caratteristiche proprie della fonetica, dell’emissione dei suoni. Infatti a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, la collana di poesia Aggetti traspose in uno studio antropologico una serie di poesie dialettali meridionali i cui versi erano solitamente impiegati nei canti popolari, a dimostrare di “seguire, con l’orecchio anzi che con l’occhio, i ritmi e gli accenti propri del canto”. Quella ricerca si intitolava Canta che ti passa e l’autrice era mia zia, , che scrive nella Prefazione: “Dovevo in quei momenti essere anche attenta ai rischi e ai pericoli derivatimi dall’osservazione partecipante, momento primo e inscindibile che sempre è legato all’analisi della materia folklorica. Uno di tali rischi per esempio è quello di sovrapporre la propria visione del fenomeno al fenomeno stesso, scambiare una tale visione per realtà osservata. L’osservazione partecipante, se è momento di iniziazione nell’ambito dell’analisi folklorica, è anche la spia di un atteggiamento di sufficienza, la coscienza di una propria indiscussa superiorità, l’instaurarsi del rapporto tra adulto e bambino della vecchia pedagogia (A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale). Si è cercato per tutta la ricerca di essere immuni e dal vizio osservazione partecipante / atteggiamento paternale e dalla ricerca dell’arcaico per l’arcaico […] Da parte mia, ho avvertito talvolta il tentativo di prevaricazione e di profanazione, la sensazione del furto di altrui identità che si è aggiunta al rimorso del non poter far nulla acché non fossero desolatamente altri: diversi da me perché portatori di una tradizione che è solo orale e quindi differente dalla mia, ma contemporaneamente vicini perché a tali radici deve andare ogni intellettuale sia esso antropologo storico folclorista o poeta, per non dimenticare l’identità”.
Il capitolo intitolato L’amore è dedicato alla , che, si dice, ha nel canto un’autentica possibilità di esprimersi: “La donna la cui adolescenza è lievitazione d’amore e preparazione al matrimonio […] Le serenate costituiscono uno dei mezzi per esprimersi […] Assai struggenti sono poi gli addii come quello della bellissima partenza del crociato che ricorda per la costruzione e i modi espressivi la duecentesca La dolce cera piangente di Giacomino Pugliese […] In questo mondo contadino in cui la condizione della donna è già segnata dalla nascita, troneggia la figura della madre che a sua volta sarà stata anch’essa un’innamorata dolce e timorosa, ora dispensatrice di consigli per la buona conduzione del matrimonio e della vita sessuale degli sposi […] Del salto sociale costituito dal matrimonio, ma non dell’effettivo cambiamento della condizione di vita della donna, fa fede il canto de La zita di Sannicandro di Bari. In tale canto a quartine in rima, al momento dell’euforia segue quello più realisticamente prosaico: la zita si appresta a divenire la cameriera del marito. Con diverse parole Engels scriveva che « … la moderna famiglia singola si fonda sulla schiavitù patente o mascherata della donna… » (, L’origine della proprietà privata e dello stato)”.
E l’acqua con cui ti lavi
la mattina
di non gettarla
perché me la porto a casa
come medicina
5.
La marea si ritrae
(per Teresa Maggio)
Sono sempre stata vecchia.
Ragnatele nodose sulle mani
e sangue coagulato.
Se ho amato,
dalla fronte in fiamme
è fuggita la figura:
placenta che non abortisce
appiccicosa da parte a parte,
riesce a vivere dopo il primo vagito,
striscia giù per il mio ventre,
come cloramfenicolo resistente,
e un’ascia risuona sul cordone.
Mi sono chiesta che peccato avevo fatto,
perché non era chiaro
quale cavità fosse perno di tutto il male
ma accanto ho scavato uno spazio
grande come una mosca
e per l’unica cosa che mi è data,
nessun amore di due occhi umidi
ma bianca bava d’indifferenza.
Così ho vissuto 72 anni quasi,
lontano da ogni passione umana.
Fratello! Alzo le braccia
e il tuo pianto ammutolisce,
entrambi non sapevamo
che anche i frutti scuri
compiono il loro ciclo e cadono.
Questa poesia è un esorcismo. Significa che ha un’urgenza e il processo interessante è cercare dove si annidi quell’urgenza, perché . Questa idea è condivisibile tra chi scrive, chi legge, la protagonista e, grossomodo, sarà un’esperienza simile anche se, probabilmente, plasmata su forme di espressione diverse. Individuare l’urgenza di un testo non è una garanzia che abbia qualcosa da insegnare, ma è un esercizio interessante per allenare sensibilità e capacità di ascolto. Ci ricorda che dall’altra parte c’è un essere umano: può anche essere defunto ma dal momento che ha scritto o qualcuno ne ha scritto a riguardo, significa che non ha nessuna intenzione di andarsene. Qui la mia urgenza era di esorcizzare un’esistenza tragica attraverso qualcosa di migliore (l’esperienza artistica) rispetto a ciò che la vita le aveva riservato. Naturalmente si tratta di una persona conosciuta e che ha inconsapevolmente lasciato un segno. Mi sono chiesto come avrei potuto fare per salvare qualcuno o qualcosa (in questo caso quell’impalpabile sensazione di mancanza, di inespresso e illegittimo). La scrittura è un buon modo, può dare l’impressione, almeno per un certo periodo, di , una , o una qualche . Allora mi sono di nuovo domandato: cosa voglio trattenere? Sicuramente il dolore. Come faccio ad “uscirne vivo”? Rendendomi conto che, per un attimo, la vita è stata beffata, voltandomi indietro dal punto privilegiato della mia posizione: la colpa originaria dell’abbandono, ragione più profonda di questa scrittura, “riesce a vivere dopo il primo vagito”, tramutandosi in qualcosa di più di una costante irrimediabile e superando quel ponte di sofferenze terrene che, pensandoci bene, adesso diviene difficile da ricordare, come quasi fosse stato solo un sogno poiché ha oltrepassato la linea dell’accertamento e della comprensione. Anche le immagini poetiche hanno una materia. Ce ne sono tante, ma soffermiamoci su una in particolare perché più archetipica: l’umido, l’acqua sugli occhi che anelano compassione, un po’ come se quell’ “umido” spesso presente nei romanzi di , per lui probabile desiderio mai realizzato di carezzevole accoglienza familiare, qui, simbolicamente, inturgidisse i frutti maledetti lasciandoli maturare fin troppo, tanto che nessuno li ha poi voluti cogliere e dunque hanno compiuto il loro ciclo solitario cadendo infine.
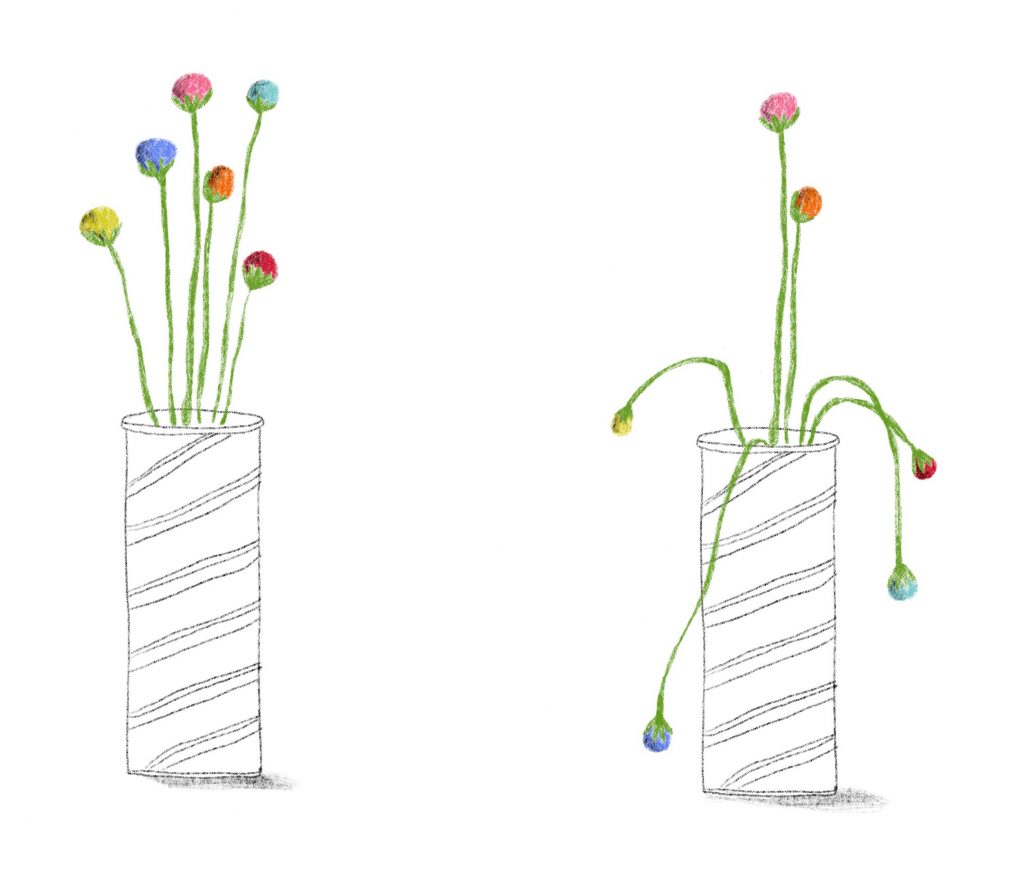
C’è una psicologia sull’acqua molto interessante, alla quale, personalmente, sono molto sensibile perché riguarda da vicino diversi aspetti folklorici del Meridione d’Italia. Vorrei prendere brevemente in esame uno dei mythos più imperscrutabili già studiato e reso artisticamente da , ossia la licantropia. Male di luna è una delle narrazioni culturalmente adottate per poter pensare il proprio dolore, per tentare di offrire alla sofferenza un progetto di conferimento di senso. L’evocazione si accentua nelle situazioni economiche precarie, nella rappresentazione di un cattivo passato, di conflitti interiori irrisolti, passività psichiche che necessitano di un esorcismo socialmente accettato (quasi calendarizzato dagli “attacchi” di luna in quintadecima per la licantropia e dalle mistiche epilessie del tarantismo) che si rivela un ethos, , una necessità di partecipare ancora a un progetto comunitario. L’orizzonte geografico di riferimento non è un caso e risulta rilevante notare le simbologie legate agli elementi della natura. Nella novella pirandelliana, Sidora va in sposa a Batà, un giovane ombroso descritto coi tratti somatici di un malinconico, quindi pallido, con occhi cavi e asciutti. Molti anni prima la madre di Batà, volendosi riposare su un’aia dopo il lavoro nei campi, dimentica suo figlio bambino esposto per tutta la notte alla luna. Batà con la luna aveva giocato e la luna lo aveva incantato. Il male gli aveva dormito dentro per anni, si era poi svegliato e ciclicamente si riproponeva. Ignara, dopo pochi giorni di matrimonio, Sidora lo aveva visto mutare sembianze. Sebbene i rapporti d’insieme risultino articolati, una certa comparazione di elementi supportano la compattezza del mito nell’ottica di cui ci stiamo occupando:. Soffermandoci su uno dei variegati aspetti, alcune testimonianze raccontano che, quando i licantropi corrono ululando nei campi, i familiari mettono fuori di casa dei secchi d’acqua che avrebbero la capacità di placare le crisi. Forse, in presagio a ciò, anche Sidora “oppressa dalla gran calura, tornava ad allungare lo sguardo alla striscia azzurra di mare lontano, come in attesa che un soffio d’aria, essendo ormai prossimo il tramonto, si levasse di là e trascorresse lieve fino a lei, a traverso le terre nude”.
(Marcel Proust, Il tempo ritrovato)
Ringraziamenti, studi, riprese, rielaborazioni, citazioni e riferimenti:
David Foster Wallace, Renata Cotrone, Friedrich Schlegel, Ugo Foscolo, Baricco & Scuola Holden, Piero Boitani, Maria Russo Rossi, aSylvia Plath, Alice Munro, Gaston Bachelard, Fulvio Librandi, Luigi Pirandello, mio nonno, mia zia Teresa.
è un violista e un grande appassionato di scrittura. Ha ricevuto il premio Sinopoli dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e suona nell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano. È sempre pronto a lanciarsi con entusiasmo in ogni progetto che presenti un minimo di follia.