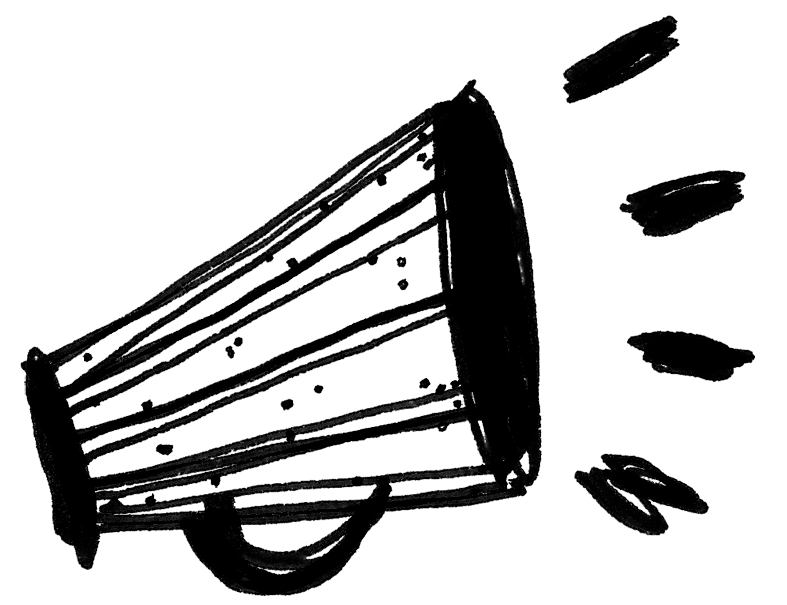Intervista a Francesco Tonucci

Quando abbiamo deciso di esplorare il tema della città, ci è subito sembrato imprescindibile rivolgere qualche domanda a Francesco Tonucci, ideatore e curatore del progetto internazionale “”. Emozionate ed entusiaste al pensiero di poterlo intervistare, abbiamo immaginato quali potessero essere le domande più indicate per indagare e comprendere al meglio il significato, il valore e la portata di un’idea, non poche volte anche realizzata, che mette al centro della città il punto di vista dei bambini.
Una volta individuate, abbiamo elaborato e scritto le domande: sarebbero state la nostra traccia nel corso della conversazione che avremmo avuto telefonicamente con il professor Tonucci.
Ciò che è accaduto realmente, però, non era quanto ci saremmo aspettate. Il racconto di Francesco Tonucci ha preso il via dalla prima delle nostre domande per tramutarsi quasi subito in un fiume di parole appassionato, convinto e pieno di calore. Il discorso, chiaro, organico, ma comunque dialogico e interessato a conoscere il punto di vista dell’interlocutore, ha inevitabilmente finito per anticipare e approfondire ogni questione che ci eravamo ripromesse di affrontare, aprendone altre a cui non avevamo inizialmente pensato.
Quanto segue corrisponde esattamente a ciò che è accaduto: non un’intervista fatta di botta e risposta, ma un vivo scambio di idee e di pensieri, una condivisione di preoccupazioni e di urgenze, un riconoscersi in un cambio di rotta necessario e decisamente possibile. L’incontro con Francesco Tonucci, così come si è svolto, ci ha reso fiduciose. Nel riportarlo nel modo più fedele possibile, nella forma di una fluida conversazione, speriamo di coinvolgere anche voi nello stesso viaggio che abbiamo fatto con lui.
Ci sono molti progetti simili, che si chiamano “Città amiche dei bambini”. Una città amica dei bambini è una città che fa molte cose per i bambini. Parlando delle città italiane, sono spesso le più avanzate, le più sensibili, che effettivamente fanno molte cose per i bambini. Nel nostro caso, l’interesse o l’ottica sono rovesciati: noi vorremmo fare delle città con i bambini o dei bambini.
Qual è la differenza? Vi faccio un esempio.
Oggi le città sviluppano servizi per l’infanzia molto sofisticati, anche di alta qualità. Se pensiamo all’Italia, il nostro paese vanta forse le scuole dell’infanzia più avanzate a livello internazionale (parlo del modello Reggio Emilia, per intenderci). Io ho potuto seguire da vicino questi sviluppi, perché ho avuto la fortuna di essere amico e collaboratore di Loris Malaguzzi, che è stato il direttore e fondatore di Reggio Children. Tuttavia, ecco, questi servizi solo apparentemente sono per i bambini. Di fatto sono servizi per le famiglie che hanno bambini.
Un nido d’infanzia, che accoglie bambini da 0 a 3 anni, offre un servizio che può avere una durata anche di 8 ore al giorno. Ecco, difficilmente possiamo pensare che questa sia una risposta adeguata alla domanda di un bambino o di una bambina di 2 anni. Semmai, risponde a un’esigenza dei genitori di questa bambina, che non sanno dove lasciarla mentre sono al lavoro.
Allora, però, l’articolo 3 della Convenzione dei Diritti del Bambino, che afferma, con molta sicurezza e con molta generosità, che è l’interesse del minore a dover essere sempre considerato in primo luogo, non è rispettato: ciò che viene tutelato primariamente nell’esempio che abbiamo visto è il diritto al lavoro dell’adulto, rispetto al quale bisogna organizzare i tempi dei bambini.
Se poi dai servizi educativi passiamo al gioco, allora le cose diventano ancora più paradossali. Il gioco dei bambini nella città moderna viene considerato un servizio pubblico che si realizza in spazi dedicati, dotati di giochi predisposti, che i bambini possono frequentare sempre accompagnati da un adulto.
Queste condizioni, però, con il giocare non c’entrano nulla. Il giocare è un’esperienza di libertà, creatività, autonomia; è un’esperienza che ha bisogno della scoperta, della sorpresa, del rischio, dell’affrontare un ostacolo e del provare la soddisfazione nel superarlo o la frustrazione nel non superarlo. Tutto questo è impossibile per mano di un adulto.
Il verbo “giocare” – è una cosa che dico sempre – non può andare d’accordo con i verbi “accompagnare”, “vigilare”, “controllare”, “orientare”, ma solo con il verbo “lasciare”. Il gioco ha la caratteristica dell’inutilità: il gioco non serve a nulla, così come il piacere. Quando noi viviamo esperienze che sono all’apice del desiderio umano, non abbiamo un programma, non abbiamo uno scopo, non abbiamo un obiettivo, e non le valutiamo dicendo “con questa esperienza ho imparato, ho guadagnato, etc.”. Allo stesso modo, il gioco è un’esperienza vissuta dai bambini apparentemente e sostanzialmente inutile, ma la cosa sconcertante è che abbiamo ragioni scientifiche per sostenere che sono le esperienze nelle quali si apprende di più in tutta la vita.
Ormai non ci sono dubbi. Sono le cose che ci hanno insegnato i maestri del secolo scorso – da Freud a Piaget, Vygotskij, Bruner: insomma, i nostri punti di riferimento – e che oggi le neuroscienze stanno verificando e comprovando: non c’è in tutta la storia di una donna o di un uomo un periodo di fertilità, di attività neuronale così intenso come quello che ha luogo nei primi anni di vita. Il che vuol dire che lo sviluppo che si crea cognitivamente, socialmente o nel campo delle abilità nei primissimi anni non avrà eguali per tutta la vita. E questo avviene prevalentemente giocando.
Allora, la città che fa delle cose per i bambini è una specie di ossimoro: a fare delle cose per i bambini si sbaglia sempre.
L’altro giorno ero in collegamento con un festival dell’architettura a Roma e mi sono permesso di chiedere a chi mi ascoltava, ovvero dei progettisti, di non progettare più spazi di gioco per i bambini.
A questo punto è legittimo che uno si chieda: d’accordo, ma allora che cosa facciamo? In cosa consiste la città dei bambini? Come progettiamo una simile città? Io risponderei che è proprio la città che si offre come spazio di gioco, che diventa giocabile, non perché moltiplica o migliora gli spazi del gioco, ma perché si offre nello spazio pubblico come spazio per giocare.
Ecco. E forse siamo in una posizione ancor più radicale, perché io credo che spetti alla città, e quindi spetti al mondo adulto, far in modo che i bambini possano uscire di casa. La prima condizione da realizzare è che i bambini escano di casa da soli. Bisogna cominciare a ragionare su che cosa è necessario perché i bambini possano avere delle esperienze di autonomia, a 2 anni, a 6 anni, a 8 anni. Naturalmente, c’è un’autonomia diversa in ognuna di queste tappe, relativamente all’età. Poi, una volta che abbiamo permesso ai bambini di uscire di casa, il problema passa a loro, non è più nostro: cosa vuol dire giocare lo sanno loro.
Un’altra condizione necessaria è avere del tempo libero. La Convenzione dei Diritti del Bambino, all’art. 21, dice che i minori hanno diritto al tempo libero e a dedicarsi al gioco. La scelta del verbo “dedicare” è significativa, perché, rispetto all’originale inglese, to engage, è già una riduzione. “Engage in play”, che è quanto compare autenticamente nella Convenzione, vuol dire “impegnarsi nel gioco”. Si tratta di un’espressione molto forte: devo dire onestamente che nemmeno io ho mai rimproverato i miei figli perché “non si impegnavano abbastanza nel gioco”. Eppure, sono queste le parole scelte dalla Convenzione, che, peraltro, non utilizza il verbo engage in nessun altro contesto con riferimento ai bambini. È proprio una scelta di valore, diciamo.
I bambini, perciò, devono poter uscire e devono avere del tempo libero, che possano gestire, ovviamente all’interno di regole. Io non ho mai pensato che debba essere un’esperienza anarchica: è giusto che la famiglia dia delle regole ragionevoli, comprensibili, e che il bambino, una volta che è uscito e ha del tempo disponibile, possa scegliere il gioco da fare e, coerentemente con il gioco scelto, cercarsi uno spazio adeguato. Non si possono pensare a priori degli spazi giusti per giocare, perché si gioca dappertutto. È come se si volesse stabilire a priori qual è lo spazio giusto per avere un rapporto affettivo con una persona: gli spazi sono tutti buoni. Bisogna aver voglia, aver desiderio, sono altre le condizioni che devono essere soddisfatte.
Ed ecco che allora tutte le volte che la città, esaminandola anche storicamente, costruisce degli spazi separati o degli spazi dedicati fa un’operazione di emarginazione. Così era il gineceo nella casa romana, che non era un privilegio per le donne, ma era la prigione delle donne. Così sono le case per noi anziani, dove in modo vergognoso sono morti anche alcuni miei colleghi nei mesi scorsi. Lo spazio dei giochi assomiglia in qualche modo a queste cose: è un modo di liberarsi di presenze scomode.
Assolutamente sì.
Il progetto La Città dei Bambini è nato a Fano nel 1991 e una delle cose che ricordo con piacere è che la città di Fano ha deciso di produrre una segnaletica turistica che si è concretizzata in lastre di alluminio che descrivevano le caratteristiche dei palazzi principali o dei monumenti fanesi: erano piantate per terra e, perciò, erano basse. La scelta era mossa dal desiderio che tutti potessero leggere: un adulto, anche molto alto, legge bene qualcosa che è in basso, ma per un bambino o per una persona sulla sedia a rotelle leggere in alto potrebbe essere impossibile.
Spesso ricordo una cosa che mi è rimasta impressa del tempo in cui c’erano i telefoni pubblici nelle stazioni: c’era una fila di telefoni – quattro, cinque o sei – a un’altezza di un metro e mezzo e poi ce n’era uno basso per gli handicappati. Tutte le volte che mi trovavo di fronte questa scena provavo una grande vergogna. Perché non li facciamo tutti bassi?, mi chiedevo. Per me non sarebbe stata una fatica fare un numero a 60 cm di altezza e si sarebbe evitato di umiliare chi fosse dovuto andare all’unico telefono che si trovava nel “suo” posto. È questo che succede quando una città pensa a una categoria come separata.
Allora, il problema vero è che i bambini, dovremmo dire da sempre, ma giuridicamente dal 1989, sono considerati cittadini e non futuri cittadini. La Convenzione dei Diritti del Bambino riconosce la cittadinanza dei bambini. E da quel momento ogni forma di emarginazione diventa un abuso, un delitto. I bambini devono ovviamente essere tutelati, ma, insieme a queste necessità, ci sono anche i diritti di cittadinanza.
Prendiamo, per esempio, l’art. 12, che è sconcertante, se lo leggiamo attentamente, perché dice che i bambini hanno diritto a esprimere il loro parere ogni volta che si prendono decisioni che li riguardano. È sconcertante, perché noi adulti non abbiamo questo diritto: i nostri governanti, sia locali che nazionali, non sono obbligati a consultarci ogni volta che prendono decisioni che ci riguardano. Nei confronti dei bambini, invece, è stata scritta una norma molto precisa, che non solo dà ai bambini il diritto di esprimere il loro parere, ma afferma anche che le opinioni dei bambini devono essere tenute in conto.
Eh, non si fa.
Nel nostro progetto noi abbiamo assunto quest’idea e l’abbiamo trasformata in una proposta concreta, che è il Consiglio dei Bambini. Noi diciamo che la città, ovvero il sindaco deve chiedere ai bambini di offrirgli l’altro punto di vista: solo così potrà essere sicuro di essere sindaco di tutti.
Mi ricordo, per esempio, di quando Veltroni, ai tempi sindaco di Roma, aprì il Consiglio dei Bambini il 20 novembre 2001, dopo aver chiesto a me e alle mie colleghe di offrire la nostra consulenza al comune di Roma. Quando ha aperto il consiglio, ha detto: “Io ho aperto questo consiglio perché ho bisogno del vostro aiuto, perché noi adulti ci siamo dimenticati di cosa vuol dire essere bambini e da oggi lavoreremo insieme per migliorare questa città”. Questo discorso, che avevamo preparato insieme, corrisponde bene al nostro impianto: il sindaco, pur avendo moltissimi collaboratori, ha solo collaboratori adulti, quindi non è capace di interpretare le altre esigenze, che ovviamente non sono solo quelle dei bambini, ma sono anche quelle degli anziani, degli stranieri, degli handicappati, delle categorie marginali. Ecco, secondo noi, i bambini sono capaci in qualche modo di rappresentare tutte queste categorie. Se un sindaco diventa capace di ascoltare i bambini, ha già fatto un bel passo in avanti per essere sindaco di tutti.
Noi abbiamo una rete di 200 città in dieci o dodici paesi nel mondo e di solito il Consiglio dei Bambini è uno strumento che i sindaci hanno.
In questo momento di pandemia, la prima cosa che ho fatto a marzo è stata mandare un videomessaggio ai nostri sindaci invitandoli a convocare virtualmente i consigli dei bambini. In molti casi è stato fatto ed è interessante notare che noi abbiamo proposto un utilizzo delle piattaforme molto diverso da quello che ha fatto la scuola. La scuola ha usato le piattaforme per mettere i bambini e i ragazzi in una situazione passiva di ascolto della lezione del professore e spesso questo non ha funzionato, perché gli studenti si sono stancati, hanno imparato meno di quanto avrebbero imparato in classe. Noi, al contrario, abbiamo utilizzato le piattaforme per ascoltare i bambini. Le piattaforme potevano essere utilizzate in questo modo. Io spero che questo esempio che noi adesso stiamo cercando di comunicare – sto proprio correggendo le bozze di un libro che ho scritto di recente raccontando queste esperienze – sia raccolto dalla scuola, perché possa conoscere modalità alternative, diciamo orizzontali e democratiche, dell’uso delle piattaforme. Se dovesse essere necessario continuare con la didattica a distanza, questo potrebbe essere un modo molto più efficace e anche molto più giusto e adeguato di usare gli stessi strumenti.
Sono d’accordo. La scuola era già in una fase regressiva e lo vediamo nelle nostre esperienze familiari. Io ho frequentato la scuola quasi 80 anni fa, ma la mia esperienza assomiglia molto a quella della mia nipotina, che ha 13 anni. La scuola che hanno frequentato i miei figli, che hanno intorno ai 50 anni, era una scuola migliore, che respirava la voglia di cambiamento diffusa negli anni Settanta e che poi è stata spazzata via. Devo dire che la pandemia, questa situazione di crisi, poteva essere un’ottima occasione per dare una svolta, perché la scuola poteva finalmente capire che da sola non ce la può fare, che ha bisogno della famiglia. Durante la pandemia, io ho fatto una proposta che in molti paesi è stata accolta, anche formalmente e anche dai ministeri: è ciò che ho chiamato “Casa come laboratorio” e che partiva dalla considerazione che, vista la situazione che vivevamo – con i bambini costretti nelle loro case –, fosse corretto ipotizzare che anche i compiti e le lezioni si svolgessero intorno alla casa o sulla casa, coinvolgendo i genitori in qualità di collaboratori della scuola, di assistenti di laboratorio. Dove è stato fatto, ha funzionato molto bene.
Purtroppo devo dire che mi è capitato di incontrare sensibilità più spiccate in paesi diversi dal nostro. In particolare, in Argentina, in Colombia, in alcune zone della Spagna. Tenga conto, per esempio, che il ministro dell’educazione argentino si è messo in contatto con me e abbiamo fatto una videoconferenza a cui pare abbiano assistito più di duecentomila persone; dopo questo incontro hanno pubblicato un quaderno, che stanno distribuendo in decine di migliaia di copie, in cui si propone quest’idea della casa come laboratorio. Certo, con questo non voglio dire che la scuola argentina sia meglio della nostra: anche lì ci sono diversi problemi. Però, ecco, sotto questo aspetto, forse la sensibilità è stata maggiore lì piuttosto che qui.
Siamo sempre lì. Abbiamo delle leggi molto esigenti e molto compromettenti: dovremmo semplicemente rispettarle. L’articolo 12 di cui abbiamo già parlato vale per tutti i paesi che hanno ratificato la Convenzione. Fra l’altro, va considerato un fatto che non viene mai detto con chiarezza: i trattati internazionali sono delle leggi di alto livello giuridico che hanno più valore delle legislazione ordinaria. Un paese, quando ratifica una convenzione, si impegna a far sì che la sua legislazione interna sia coerente con il trattato internazionale. In questo caso, la consultazione dei bambini è un obbligo che spetta a tutte le strutture sociali. Noi lo chiediamo ai sindaci, ma lo chiediamo anche ai dirigenti scolastici. Tutte le scuole, per essere legali – non dico per essere buone, ma per essere legali – dovrebbero avere delle forme di consultazione degli alunni. Noi adesso stiamo ascoltando in televisione tutti i giorni quanti sono i casi, cosa succede nelle scuole, ma nessuno pensa, per esempio, che una delle soluzioni più vantaggiose potrebbe essere quella di far diventare gli studenti fin dai primi anni, fin dalla scuola dell’infanzia, corresponsabili delle scelte che facciamo. In questo modo, oltre che responsabili, bambini e ragazzi possono rendersi partecipi. Le regole vanno stabilite a un tavolo al quale si siedono la città, la scuola, la famiglia e gli alunni. Se le regole nascono in quel contesto è probabile che vengano rispettate, altrimenti alcune di queste componenti diventeranno progressivamente antagoniste: una volta saranno le famiglie, una volta sarà la città che non darà risposte adeguate e spesso saranno gli studenti che, appena trovano un varco, lo utilizzeranno per trasgredire.
Il protagonismo è un’esperienza fondamentale di tutto il processo educativo. Se noi rispettiamo l’articolo 12, che peraltro abbiamo deciso noi, perché la Convenzione non l’hanno scritta i bambini, se rispettiamo questa scommessa e permettiamo che bambini e ragazzi siano protagonisti, allora sono sicuro che molti problemi troveranno una soluzione.
è un ricercatore associato dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano. Ha dedicato la sua attività di ricerca ai temi dell’educazione, specialmente infantile e alla formazione dei docenti. Da più di venti anni è responsabile del progetto internazionale “La città delle bambine e dei bambini”, che ha creato una rete di più di 200 città in Italia, Spagna, Sudamerica e ora in Libano e Turchia.
Professore honoris causa della Pontificia Unicìversità di Lima (Perù). Dottore honoris causa della facoltà di Architettura dell’Università Nazionale di La Plata (Argentina).
Tra le sue pubblicazioni: “Guida al giornalino di classe” (Laterza, 1980), “Appunti sulla scuola dell’infanzia” (Fabbri Ed., 1981), “Con gli occhi del bambino” (Fabbri Editori, 1981), “Bambini si nasce” (La Nuova Italia, 1987), “Bambini si diventa” (La Nuova Italia, 1989), “La solitudine del bambino” (La Nuova Italia, 1995), “La città dei bambini” (Laterza, 1967), “Se i bambini dicono ‘adesso basta!’” (Laterza, 2002). Il suo ultimo libro uscito in Italia è “Un sorso dopo l’altro. Disegni e pensieri per tuffarsi nel mondo dell’acqua” (Palombi, 2008). Nel catalogo di “Orecchio acerbo”, tutti illustrati da Osther Mayer: “Il paese dei quadrati” (2002, millemillimetri), “Il paese dei cerchi” (2003, millemillimetri), “Il paese dei quadrati + il paese dei cerchi” (2006).