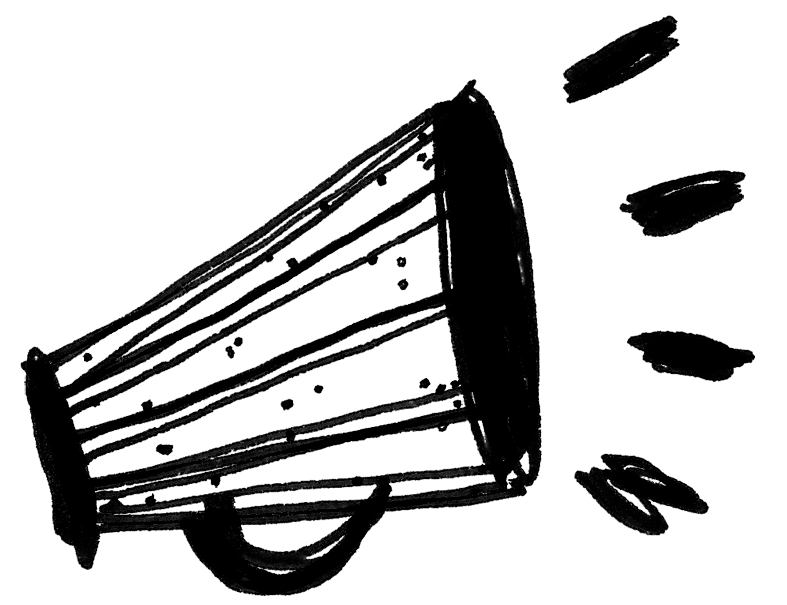Intervista a Christian Raimo a cura di Flavio Pintarelli
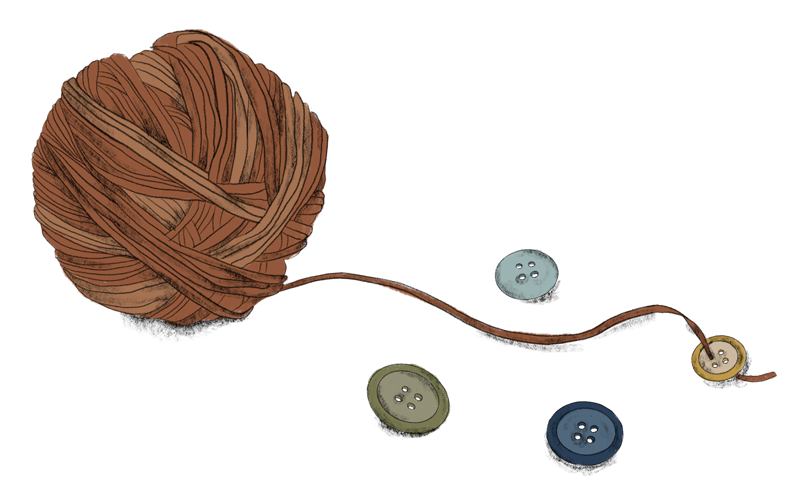
L’idea di intervistare Christian Raimo mi è venuta subito in mente quando, in redazione, abbiamo iniziato a discutere circa la possibilità di dedicare un numero di FarFarFare alla politica. Ho conosciuto Christian quasi dieci anni fa, nei panni dello scrittore e dell’intellettuale. Seguendolo sui social ho poi scoperto che, per lungo tempo, ha fatto anche il mestiere di insegnante. Poi, a un certo punto, è diventato assessore alla cultura del III Municipio di Roma.
Sì, c’è un filo rosso e non lo vedi solo tu. È anche nella mia testa. Questo filo rosso è pensare che il motore politico fondamentale, in questo momento in cui stiamo uscendo dalla lunga fase dell’antipolitica, possa essere lavorare sull’educazione pubblica. Su processi di pedagogia popolare e di autoformazione. In un modo o nell’altro, nei vari ruoli che ho assunto e che assumo penso di voler fare proprio questa cosa.
Quando insegnavo, a un certo punto mi sono accorto che non mi bastava più limitarmi a fare bene il mio mestiere. Allo stesso modo come intellettuale che si occupava di scuola ho capito che interrogarmi sulle cause dei problemi politici che notavo non mi bastava più. Volevo impegnarmi nelle soluzioni di quei problemi politici. Perché erano e sono enormi, e dolorosi. Sono . Esperienze comuni a chi vive la scuola ogni giorno.
Perciò ho fatto la sola cosa che so fare in queste situazioni: mettermi a studiare. Ho avuto il privilegio di potermi prendere 3 anni per fare una tesi di dottorato sulla pedagogia d’avanguardia del dopoguerra, confrontandomi con questi temi.
Ho potuto così approfondire esperienze chiave di quella temperie come quella del Movimento di Cooperazione Educativa (MCE); quella del Centro Educativo italo-svizzero (Ceis) di Margherita Zoebeli; Scuola viva di Carmela Mungo alla Magliana; i Centri di esercitazione nei metodi dell’educazione attiva (Cemea); la Scuola-Città Pestalozzi di Firenze, i COS di Capitini e il CEPAG di Guido Calogero e Angela Zucconi. Tutti modelli di educazione e pedagogia pubblica permanente, che sono anche modelli politici.
Per me, che sono arrivato alla scuola dopo aver provato a lavorare con la cultura in vari campi (dall’editoria al giornalismo all’accademia), lo studio di queste esperienze ha rappresentato una grande fonte d’ispirazione. Prima, quando facevo il lavoro culturale, provavo grandi frustrazioni. Non solo per la precarietà a cui quel tipo di lavoro è condannato, ma anche perché i ruoli che interpretavo in quell’ambito non mi davano la possibilità di incidere politicamente. Per qualche tempo ho pensato che fosse importante cercare dei referenti politici a cui affidare quel lavoro prepolitico che è la riflessione intellettuale su alcune questioni. A un certo punto mi sono accorto, mi sono reso conto, che non c’erano. Mancavano le persone per fare questo passaggio e ho provato a colmare il vuoto.
Se mi fai questa domanda mi viene in mente un’immagine. È quella dello sgombero di piazza Indipendenza, a Roma, nel 2017. Anche se era fine agosto, quando a Roma non c’è quasi nessuno, fu un episodio molto seguito, perfino dalla stampa internazionale. Un po’ perché piazza Indipendenza è centrale, sta a 100 metri dalla stazione Termini. Ma soprattutto per le dimensioni. È uno sgombero che ha toccato quasi 1000 persone.
All’epoca collaboravo più attivamente con Internazionale, che ha la sede a 50 metri da dove avvenne lo sgombero. Io ero già in piazza, perché, mi dico, non posso non seguire quello che accade. Altri colleghi, invece, erano rimasti in redazione. Alcuni di loro, all’ora di pranzo, escono per andare a mangiare e si ritrovano nel marasma. Prendono anche qualche manganellata e qualche spintone dalla polizia. Insieme torniamo in redazione e ci mettiamo a tradurre pezzi di testate straniere che parlano di quanto sta accadendo a poche centinaia di metri da noi. Il nostro lavoro di controinformazione, di cura dell’informazione non riesce a causare un’attivazione, nemmeno in noi stessi.
Questa cosa mi lascia attonito, come mi lascia attonito un’assenza: quella delle istituzioni. In piazza c’è la polizia, ci sono le persone che vengono sgomberate, ci sono attivisti, militanti, giornalisti, qualche politico di secondo o terzo livello. Non c’è nessun assessore comunale, nessun parlamentare, nessun politico di rilievo. Eppure la cosa è grossa perché, appunto, ne parlano anche i giornali esteri. In piazza ci sono gli avversari e gli alleati, però mancano gli interlocutori. Più tardi ci rifletto sopra e penso che non si può creare conflitto, e quindi fare politica, se la classe dirigente con cui dovresti confrontarti è inesistente. In condizioni simili, l’unica cosa da fare è sostituirla.
Questo è, chiaramente, un discorso complessissimo, su cui mi sto ancora interrogando. Penso che nella dimensione politica che ci troviamo a vivere sia stata molto sottovalutata l’importanza della
Col Novecento non abbiamo solo fatto piazza pulita delle ideologie, abbiamo cancellato anche le interpretazioni. È come se fossero venuti meno, con le loro forme di critica (politica, psicologica e artistica) i tre cosiddetti “maestri del sospetto”. Ovvero Marx, Freud e Nietzsche, che erano stati i nostri numi tutelari ovunque, anche nelle sconfitte.
Nello spazio lasciato da questa cancellazione hanno preso vita delle pseudo categorie, che sono dispositivi molto funzionali. Per esempio, a Roma come in altre città, il dispositivo decoro-degrado. È qualcosa che non ha alcun tipo di valenza scientifica. Non ha una letteratura e nemmeno una capacità di riconoscimento del presente. Sono due pseudo concetti, che tuttavia producono politica. O, meglio, producono una dimensione estetica che, a sua volta, produce una dimensione politica.
Al momento combattere contro queste retoriche è una battaglia quasi persa. Però, per me, è determinante provarci. Come intellettuale infatti è molto importante saper riconoscere le categorie su cui organizzare le linee di conflitto. Ti faccio un altro esempio molto romano: la dialettica tra centro e periferia. Ho capito quanto sia inservibile. Opacizza le vere linee di conflitto. Ha poco senso anche parlarne, perché la città ha enclavi e ghetti che si distribuiscono al suo interno secondo altre linee, altri vettori.
Il problema fondamentale, allarmante, non è il degrado delle periferie. Ma sono i 16.000 senzatetto, i 5.000 rom nei campi, le diverse migliaia di persone nelle prigioni e quelle distribuite tra CIE, SPRAR e altre forme di ghetto o campo. A Roma ci sono 30.000 persone senza diritti di cittadinanza, ghettizzate con dei dispositivi che sono prima di tutto estetici, immaginari, che si rafforzano l’uno con l’altro. Perciò è fondamentale cercare di trovare il modo di rompere il dispositivo e, soprattutto, di lavorare sull’invenzione di un’altra estetica, di un altro immaginario.
Vista dall’interno, la stanza dei bottoni è vuota. Il piano politico è quasi del tutto inesistente. C’è un piano decisionale, una cinghia di trasmissione del potere che funziona nel modo più autoritario che io abbia visto, nel modo meno dialettico. Le persone che fanno politica passano il loro tempo ad abitare sia questo piano decisionale che quello, altrettanto fondamentale, comunicativo. La decisione viene presa in quanto viene comunicata, nel momento in cui viene comunicata. I luoghi dove si decide sono le conferenze stampa.
Penso che in questo momento la televisione abbia tanta importanza quanto sia trascurata dai movimenti. Nessuno pensa a stare in televisione e a come starci. È un errore, perché è lì che si forma l’opinione pubblica del paese. Tempo fa avevo provato a fare un reportage da fermo: una settimana a guardare la tv 16 ore al giorno. Facendolo mi sono accorto che in televisione gli stranieri non esistono più, se non nei telegiornali. Non ci sono più nemmeno quelli che avevano il ruolo dei simpatici turisti, come Don Lurio, le Gemelle Kessler o, più di recente, Mika o Skin. Non esistono più neanche in quella funzione.
Lo stesso vale per le donne, che, nella televisione italiana, a parte qualche eccezione, non sono mai interrogate in quanto esperte. A loro resta una funzione di conduzione. Gruber, Berlinguer, Annunziata fanno le moderatrici, con un modo maieutico. Sopportano e alle volte alimentano un tasso di violenza maschile che produce disastri dal punto di vista dell’educazione del pubblico.
La televisione è fondamentale. In rapporto al web è egemonica. Il web riprende il contenuto televisivo. È un corollario della televisione, ne segue l’agenda. Lo stesso i quotidiani, ma un gradino più in giù lungo la scala.
Per questo penso che intervenire in televisione sia fondamentale. Mi interessa e interesserebbe farlo con un progetto, che sia come ospite o come uno che prova a fare dei programmi. Ma bisogna intervenire in televisione. Penso che lì si possa fare un enorme lavoro politico.
Posso parlare per me, e risponderti che, in questo, il Teatro Valle è stato una grande palestra. Mi ha insegnato moltissimo su come ragionare di politica in termini di modelli. Un pezzo del modello del Valle ho provato a riprodurlo in Grande come una città. Oggi usciamo da una lunga fase, che identifico con l’antipolitica. È un decennio che va dal 2007 al 2018 circa. È il periodo in cui sono nati il PD e il suo antagonista, il Movimento 5 Stelle. Ma è anche quello in cui è uscito La casta, il libro che ha definito il linguaggio e l’estetica di questa fase. Siccome i percorsi politici sono molto accidentati è importante avere una struttura, un esoscheletro. Soprattutto comunicativo, perché questo è, per me, oggi, il piano di conflitto che funziona di più e meglio. Il Teatro Valle aveva questa caratteristica. Sembrava che succedesse un mondo lì dentro, ed era così. Questa capacità comunicativa permetteva forme di elaborazione politica che hanno bisogno di altri tempi, dialettiche e conflitti per poter maturare. Insomma, non si passa dall’antipolitica alla politica con uno schiocco di dita. Altrimenti si producono solo forme e figure di testimonialità che al massimo possiamo prendere come testimoni come Carola Rackete, Mimmo Lucano o Liliana Segre. Persone esemplari, importanti per quello che hanno fatto. Ma quello non è un modo per imparare a fare politica, per creare organizzazioni, e soprattutto per formare culture politiche. Ed è questo ciò di cui abbiamo bisogno.

(1975) è nato, è cresciuto e vive a Roma. Ha pubblicato: per minimum fax le raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e Le persone, soltanto le persone (2014); per Einaudi i romanzi Il peso della grazia (2012), Tranquillo prof, la richiamo io (2015), La parte migliore (2018) e il saggio Tutti i banchi sono uguali (2017); per Piemme il pamphlet Ho 16 anni e sono fascista (2018). Per Laterza ha collaborato ai volumi collettanei Sono come tu mi vuoi. Storie di lavori (2009), Contro Roma (2018) e Parole ostili. 10 racconti (2018).