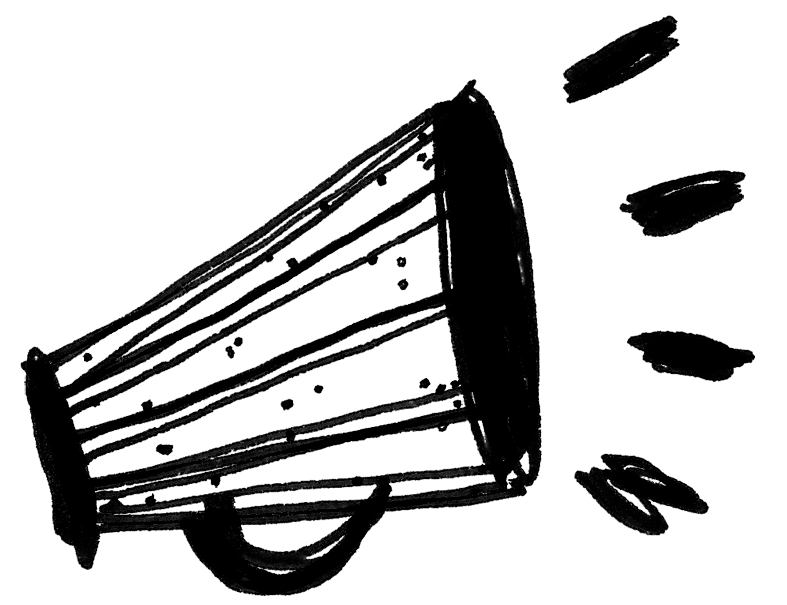Facciamo un Gioco
Intervista a Luca Boscardin
Tu sei un designer di giocattoli. Da dove è nato il desiderio di questa professione? È maturato nel tempo o è stato un obiettivo che avevi chiaro fin da subito?
Ho iniziato studiando architettura a Venezia e la progettazione è la parte che ho amato di più. Man mano che andavo avanti nel mio percorso, ho capito che non mi importava più di tanto che cosa si progettasse, se un edificio, una grafica o un oggetto: i passaggi erano sempre gli stessi.
Tuttavia, ho anche realizzato come non riuscissi a mettere nulla di me, del mio modo di progettare, in lavori dalle grandi dimensioni. Perciò, piuttosto che palazzi o ponti, ho deciso di dedicarmi al progetto di palazzi, ma in cartone, di macchine di legno, di animali in stoffa. Insomma, ho deciso di diminuire e di rimpicciolire la scala del progetto in modo tale da poter mettere un po’ del mio in quello che stavo facendo.

Nella scelta della mia professione, poi, ha giocato un ruolo anche la mia curiosità, che è una caratteristica che condivido con molti altri designer e progettisti. È come se fossimo ancora un po’ bambini nell’essere entusiasti di vedere, capire, toccare, annusare come è fatto qualcosa. Mi trovo spesso ad avere davanti, per esempio, un albero e a immaginare a come potrei smontarlo e rimontarlo attraverso un incastro; o a come potrei permettere di farlo in modo sempre diverso. Questo esercizio mentale, che ripeto con molti oggetti, è uno dei principi alla base del mio modo di progettare e, se ci pensiamo, è in se stesso una specie di gioco.
Non dirò che l’amore per questa professione è venuto da sé. Piuttosto, è maturato col tempo, provando e provando quello che mi faceva battere il cuore. Ho tentato e inseguito le mie capacità finché non sono arrivato al mondo dei giocattoli. Mondo che, tra l’altro, mi ha permesso di non rispondere in modo definitivo alla domanda che si fa ai più piccoli: “Che cosa farai da grande?”. Nel lavoro che faccio, un giorno sono un esploratore di animali fantastici attraverso un domino, un altro, progettando una macchina spaziale, divento un astronauta, e il giorno dopo ancora, realizzando una struttura in cartone, sono un architetto. Probabilmente, è proprio il non sapere cosa fare e il continuare a giocare ad avermi portato a diventare un progettista di giocattoli.
Se ti chiedessi di definire la parola “gioco”, che cosa ci diresti?
Il gioco è un modo di imparare. Anzi, è il modo di imparare più bello, perché si ha modo di apprendere attraverso il divertimento, da soli o in compagnia.
Il gioco è tradizionalmente legato al mondo dell’infanzia, ma non è esclusiva di questa fase della vita: tutti giochiamo, anche se in modo diverso. Quello che cambia, secondo me, è che mentre per il bambino attribuiamo al gioco un valore educativo, pensando all’adulto, lo definiamo uno svago.
Parliamo del tuo gioco Siamo tutt* pari. Non credo di sbagliare se dico che si tratta di una rivisitazione del memory. Una rivisitazione molto importante, che ha a che fare con un tema decisamente attuale. Vuoi raccontarci qualcosa di più di questo progetto?
La contemporaneità è tra le chiavi fondamentali per noi progettisti. Chi fa il mio lavoro non può vivere sulla Luna, ma deve essere ben presente sulla Terra per offrire delle risposte ai problemi della nostra società attraverso quello che facciamo, si tratti di un’architettura, un prodotto o, appunto, un giocattolo.
Attualmente, una delle questioni più calde riguarda senz’altro l’accettazione della diversità, anche in merito alle caratteristiche del corpo. Siamo tutt* pari è il tentativo di proporre anche ai più piccoli una riflessione su questo tema.
Il pregiudizio nei confronti dell’altro è qualcosa che riguarda prevalentemente gli adulti: le bambine e i bambini, in quanto tali, ne sono più immuni di noi. Tuttavia, proprio perché si tratta di qualcosa che rischia di emergere successivamente, ho immaginato questo gioco proprio sulla base di quanto ho affermato prima: giocando si impara e questo gioco vuole essere un modo di educare all’accettazione, alla tolleranza e all’uguaglianza.


Il senso sta proprio nella modifica alla versione originale del gioco. Nel Memory classico si devono trovare due tessere identiche, mentre qui si accoppiano due tessere analoghe, ma che condividono il medesimo significato: non importa se sono una più piccola dell’altra o di colore diverso. Talvolta, poi, la coppia non è stabilita a priori. Nel caso degli organi genitali, per esempio, c’è la libertà di scegliere come abbinarli.
Come hai stabilito che cosa inserire e che cosa togliere, nel pensare ai nostri corpi?
Senz’altro, come in ogni progetto, abbiamo dovuto togliere. Le variazioni sul tema possono essere infinite, e questo vale in particolare per l’aspetto umano, in cui la natura si sbizzarrisce in modi incredibili.
In generale, cerco sempre di eliminare tutto ciò che non serve: il superfluo, il dettaglio viene tolto per lasciare spazio a ciò che è importante ed essenziale. Sono convinto che questo modo di procedere ci avvicini a un buon design. In Siamo tutt* pari, perciò, ho tolto tutte le parti che non erano chiare o che mi sembravano meno forti rispetto ad altre.
Ci sono poi scelte di altro tenore, come quelle di tipo economico. In un gioco come questo, per esempio, il numero di tessere prodotte deve essere economicamente giusto. Inoltre, realizzandone troppe, creeremmo eccessive difficoltà nel gioco.
L’idea di togliere torna anche nei disegni presenti sulle tessere, dove mi sembra proprio che tu sia andato a individuare l’essenza: il corpo materno, evidenziato nel suo interno, al di sotto della pelle, della superficie; una mano, che rimane tale anche senza tutte e cinque le dita. Mi sembra che proprio il togliere sia alla base della ricerca di quell’unicità e uguaglianza di cui parlavi, non è così?
È assolutamente così, e ti ringrazio per averlo sottolineato.
E poi, altrettanto importante, è la scelta grafica: il ritmo di colore pieno e vuoto garantisce la bellezza del prodotto, ingrediente per me fondamentale a cui non rinuncio mai nei miei progetti. La bellezza, intesa non solo come accostamente di colori, ma anche come scelta del materiale o attenzione al suono di un oggetto, è un valore e, al pari dell’uguaglianza e dell’unicità, merita di essere oggetto di educazione per i bambini.
La bellezza, per me, è cura. Nei miei progetti faccio in modo che nulla sia lasciato al caso, perché credo che l’attenzione sia una forma di rispetto nei confronti del destinatario del mio gioco.

Ci sono altri giochi, oltre a Siamo tutt* pari, a cui sei particolarmente affezionato e di cui ci vuoi parlare? Per il concetto che esplora, o per il momento della tua vita in cui l’hai ideato…
Poco fa dicevo che Siamo tutt* pari, rispetto al classico Memory, consente di accoppiare tessere in modo più libero, perché, se alcune combinazioni sono scontate, altre non lo sono affatto ed è il giocatore a scegliere come crearle. Questa libertà, questa possibilità di immaginare, è un tratto comune a tutti i miei progetti e, a questo proposito, vorrei menzionare il primo giocattolo che ho progettato e che risale a undici anni fa. Si tratta di una città in cartone, fatta di moduli a incastro che si ripetono e che permettono di costruire assecondando l’unica regola del gioco, ovvero che non c’è una regola nell’assemblare la città. Mi è capitato di fare tantissimi workshop con questo prodotto, che permette ai bambini sia di creare città diverse sia di comunicare tra loro. Ricordo benissimo una bambina che aveva creato la sua città inserendo solo di elementi naturali – colline, alberi, cespugli, fiumi, prati, etc. -: era chiaro che stava comunicando la stanchezza nei confronti di città come Milano o Torino e il suo bisogno di natura; stava esprimendo le sue emozioni.
La libertà di dare voce a se stessi è possibile, però, proprio perché c’è un limite pratico: l’incastro è quel dettaglio che consente di non essere di fronte alla vertigine del foglio bianco, del mare di libertà eccessivo che non permetterebbe di esprimersi in modo altrettanto efficace.

Un altro gioco che vorrei menzionare è Animal Factory, un progetto a cui sto ancora lavorando. Il processo creativo è coinvolgente, così come quello di produzione, perché mi portano a creare continuamente forme nuove (era stato così anche per la realizzazione degli animali a dondolo) in un esercizio di sintesi grafica che mi diverte molto. Anche il fatto che la scala sia così realistica è sorprendente: è sempre un bel colpo trovarsi di fronte una giraffa di sei metri.

Non mi stupisce che, nelle prime prove che abbiamo fatto, questo gioco sia giocato tanto dai bambini quanto dagli adulti.
Ho la sensazione che questo progetto porti tutti sullo stesso piano. Bruno Munari diceva che i bambini vivono in un mondo di giganti. Ecco, forse, Animal Factory immerge anche i grandi in un mondo di ancor più giganti.



Luca Boscardin vive e lavora ad Amsterdam, come designer di giocattoli e illustratore.
Nel 2016 ha lanciato il brand di giocattoli BLUC con una collezione di animali a dondolo, esposti al Vitra Design Museum e a La Triennale.
Ha pubblicato con Corraini Edizioni Tutti in Fila, Scarti d’Italia e Siamo Tutt* Pari.
Animal Factory (2021) è un parco giochi per grandi e piccoli, con strutture che hanno
forme di animali.