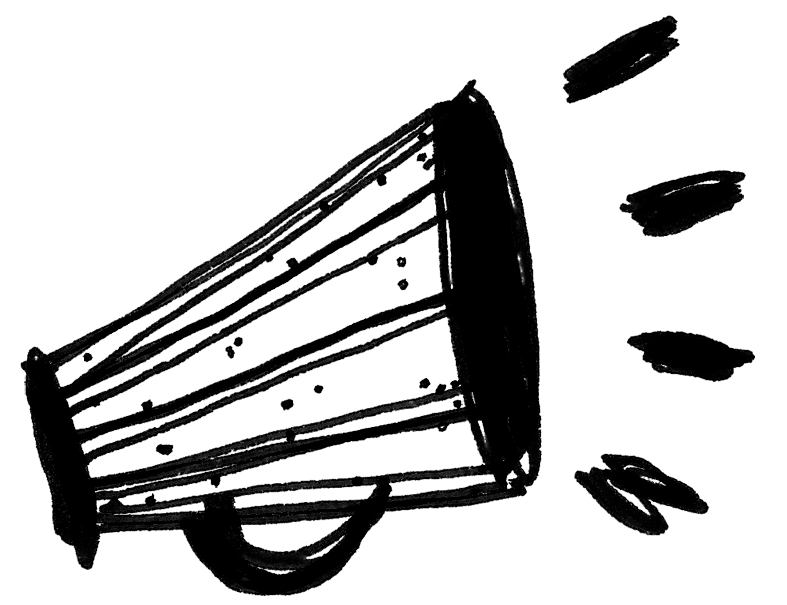I luoghi del cambiamento
Laboratorio a cura di Wanda Cronio

Quando ero bambina, nel paese in cui sono nata, la soglia tra la casa e la strada era piuttosto elastica. Si cresceva all’aperto, tra i vicoli e tra le famiglie del vicinato, interagendo con un mondo vivo che ogni giorno era nuovo e discontinuo.
I luoghi in cui i bambini di oggi sperimentano le esperienze della loro crescita sono, al contrario, spazi dai confini rigidamente controllati dagli adulti, edulcorati e pacificati, contrapposti all’imprevedibilità di ciò che è vivo, che tocca, urta e commuove.
Venuta meno la ricchezza e l’ambiguità dei luoghi informali e semipubblici di un tempo, ciò che ancora resiste come possibile ambito di esplorazione e scoperta autonoma per i bambini sono gli spazi terzi, residuali, borderline, guardati con sospetto dagli adulti perché non sempre corrispondono all’estetica del belvedere. Spazi invisibili, pur trovandosi spesso a pochi passi da casa.
Mi riferisco agli incolti e inselvatichiti: un giardino abbandonato, il ramo morto di una ferrovia, una scarpata, una spiaggia d’inverno… Luoghi dove la natura non “organizzata” risorge a dispetto di ogni barriera o di ogni costrizione, tessendo e ritessendo nuove versioni di mondo.
I bambini, che si accostano alla diversità con stupore, li riconoscono come luoghi della trasformazione, della differenza e dell’alterità, dove la forza della vita non cessa di inventare nuova vita.
L’attenzione a questi spazi terzi come luoghi di esperienze significative implica non solo la scelta di uscire fuori dalla “secure zone” dello spazio organizzato con una gita “fuori porta”, ma soprattutto l’essere disposti, come educatori, a muoversi fuori dalle cornici del proprio sapere e saper fare. Significa cioè scegliere di procedere secondo la natura mobile e imprevedibile di un progetto non lineare e non definito in partenza per andare incontro al cambiamento (nei termini di tensione e superamento): andare fuori, oltre la soglia.
Durante una gita “fuori porta” il contesto può essere al contempo strumento di trasformazione. Sabbia, ghiaia, acqua, alghe, erba, muschio, foglie, bacche, sassi, giunchi, canne, conchiglie… Tutto ciò che si trova disponibile in situ, trasportato dal vento o dall’acqua, nasconde opportunità feconde in attesa di essere risvegliate.
Un leggero bagaglio con pochi strumenti basici (forbici, spago, pinze) e pochi materiali (stecchi da spiedo, carta velina, plastiche trasparenti, reticelle e qualche materiale occasionale) trasportati in zaino basta per disporre di una cassetta degli attrezzi sempre pronta per avventure progettuali estemporanee.
Il fare e il disfare dei bambini si crea spontaneamente come espressione di un rapporto vivo di interazione con l’ambiente, con azioni che non si configurano mai come opere concluse o durevoli, perché ciò che nasce viene distrutto poco dopo o, se il materiale impiegato è esclusivamente organico, abbandonato all’azione della natura e al mutamento del tempo.
Estemporaneo ed effimero è il segno di un dialogo con il luogo che la ospita, che i bambini imprimono con una marcatura lieve e transitoria, segno del loro passaggio e frutto di un cammino che amplifica l’immaginazione e genera una trasformazione, cioè una nuova visione del mondo.
Parco giochi per uccellini
Se ci troviamo a camminare nei pressi di un laghetto e l’aria è calda e ricca di pollini, tante creature ci volano intorno. Alcune, piccolissime, ci ronzano nelle orecchie o ci sfarfallano sul naso; altre, più timide e riservate, girano al largo, in alto sulle nostre teste.
Sono passeri, scriccioli, cardellini, pettirossi, merli, fringuelli, ballerine, storni o altri piccoli uccellini. I loro occhi ben sviluppati possono vederci da molto lontano, scorgendo e spiando, una per una, le briciole della nostra merenda. Molti di loro prediligono frutti, semi, grani di cereali, teneri germogli. Altri invece si nutrono di proteine, come insetti, larve, bruchi e vermicelli, o di sostanze zuccherine come nettare e miele. Ma anche senza i vermicelli, la nostra merenda è un cibo ghiotto anche per loro.
Nasce così, in un bel giorno di primavera e nei pressi di un laghetto, l’idea di offrire un lauto pasto agli uccellini.
Per il buffet:
- Tartine di briciole di biscotto in bagna di succo d’arancia
- Tranci di brioche con bocconcini di mela
(è quello che i bambini trovano nei loro fagotti, ma sono ammessi anche altri ingredienti come barrette di cereali, di uvetta passa o di granella, torta secca o pancarrè. Vietati sandwich e salatini!)
Una tavola imbandita sull’erba sarebbe il massimo per il nostro party, ma qualcuno dice che le formiche, troppo numerose, potrebbero lasciare i nostri ospiti a becco asciutto… Meglio staccarsi da terra e appendere la merenda per aria. Sembra un’ottima idea, ma i rami degli alberi intorno sono troppo alti e non offrono appigli. Cos’altro ci possiamo inventare?
Guardiamoci intorno…
Il terreno umido e spugnoso in cui cresce la vegetazione circostante è una zuppa densa di grovigli di radici e sterpaglie che si presta molto bene a fare da supporto morbido per piantare giunchi, ramoscelli, canne; le foglie delle piante, nella loro varietà di forma e dimensione, verdi o secche, possono essere attorcigliate, annodate, intrecciate. È quanto basta per costruire una pergola su cui appendere i nostri piatti: erba robusta per legare le canne, foglie intrecciate per creare giacigli.
Sospesa su tralci di verdi altalene, colme di briciole e polpa di frutta, la cena è servita. Possiamo andare.
Stasera gli uccellini faranno festa.
Ma… dopo il party, che fine faranno le altalene?
Ci è giunta voce che in quel preciso punto nei pressi del lago, in alto sui giunchi e dondolato dal vento, resiste ancora (ben curato da becchi esperti) un parco giochi per uccellini.

Wanda Cronio nasce a Palermo nel 1961. Formata in Belle Arti, dopo gli studi si trasferisce all’estero dove partecipa a progetti di agrosilvicoltura e dove si approccia alle prime esperienze informali di educazione creativa per l’infanzia presso comunità agricole. Nel 2006 pubblica un ciclo di illustrazioni dedicate all’infanzia per la rivista letteraria tedesca Das Gedicht di A.G.Leitner. Tornata in Italia nel 2009, si specializza con un Master sul Metodo Bruno Munari® e lavora come atelierista presso istituzioni pubbliche e private. Dal 2015 vive a Mazara del Vallo, dove lavora come responsabile dell’Area Progettazione e Design per l’Impresa Sociale Sociale “Solidarietà e Azione”, una cooperativa da anni impegnata in progetti e servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie provenienti da contesti di povertà educativa.