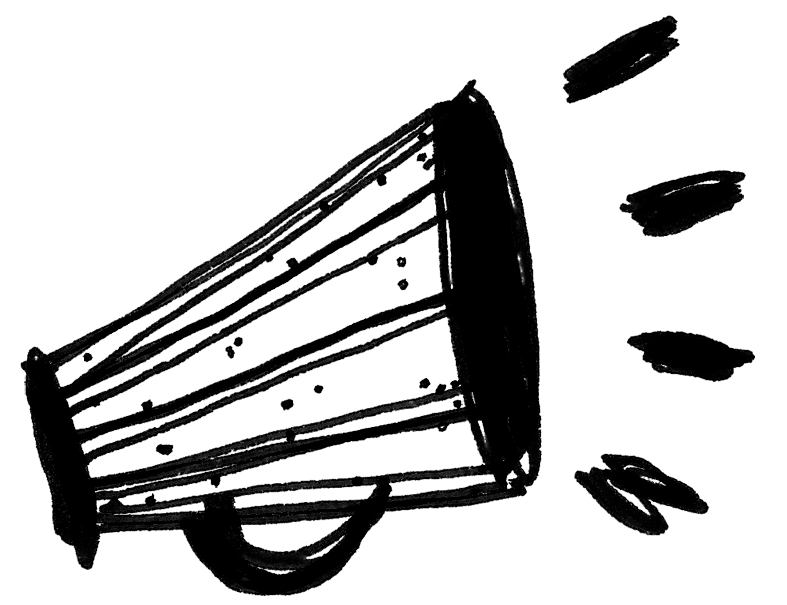La “Sventurata musica”
Articolo a cura di Danilo Faravelli

La musica non è da essere chiamata altro che sorella della pittura, conciosiach’essa è subietto all’audito, secondo senso all’occhio (…). Ma la pittura eccelle e signoreggia la musica perch’essa non more immediate dopo la sua creazione, come fa la sventurata musica, anzi resta in essere, e ti si dimostra in vita quel che in fatto è una sola superfizie.1
Sono parole di Leonardo da Vinci, che pure, oltre a sapere “sonar di leuto”, era tutt’altro che estraneo all’arcana arte del comporre, del combinare suoni dilettevolmente.
In ogni caso, potrebbe il significato della sua comparazione essere più chiaro? Stando alla sua visione dell’agire estetico, a fare della musica un’arte “sventurata”, un’arte di valore inferiore a quello della pittura, bastavano due semplici inoppugnabili verità: che essa dipendesse dal senso dell’udito, secondo, ovvero inferiore, a quello della vista, e che le fosse categoricamente preclusa la possibilità di sopravvivere al proprio connaturato divenire, immobilizzandolo a niente più che all’illusorio livello di “una sola superfizie”.
Posta di fronte a un giudizio così poco lusinghiero, formulato oltretutto da una delle intelligenze più versatili e celebrate della nostra tradizione culturale, la musica dovrebbe aversene a male? Davvero non ne avrebbe motivo, dato per assodato che essa è il luogo stesso dell’inafferrabilità che seduce e dell’inconsistenza che si modella in forme.
La musica è aria vibrante plasmata dalla fantasia; è un elemento incorporeo a tal punto consapevole del proprio inesplicabile gassoso magnetismo da aver assegnato proprio al vocabolo aria il compito di innalzare allo status di idea l’essenza ultima del proprio compiaciuto e non riscattabile assoggettamento alla contraddittoria tirannia del tempo, signore supremo di una caducità inarrestabile e inestinguibile.
Da poco meno di un migliaio d’anni, dal Medioevo dei primi esperimenti polifonici, la musica tende infatti a porgere il meglio di sé attraverso la definizione di aria, laddove la purezza del nascere e contestualmente morire di una melodia che va dipanandosi istante dopo istante finisce per contrapporsi all’ingenua e vana presunzione di stabilità architettonica, di statica monumentalità, di masse di suoni in sovrapposizione concertante, sinfonica o corale. Scaturisca da una voce umana o dalle materie usate per costruire arnesi capaci di simulare la magia del canto, l’aria acusticamente intesa è ciò che la musica elegge da secoli a saldo fallimentare dello smisurato debito contratto con l’aria che, in qualità di elemento, da sempre si presta a fare da tramite di vibrazioni provocate e propagate per suscitare i più disparati stati d’animo.
È un debito colossale, ormai incalcolabile, accumulato nell’arco di millenni laddove, su questo nostro pianeta, si siano moltiplicati e abbiano convissuto individui convinti che la parola potesse oltrepassare, ora semplicemente ora sontuosamente, i confini ristretti delle intonazioni d’uso ordinario.
NOTE
1 Paola Barocchi (a cura di), Scritti d’arte del Cinquecento (Volume II), Torino, Einaudi, 1978, p.250

Danilo Faravelli, nato nel 1953, si è appassionato alla musica d’arte negli anni dell’adolescenza. Sin da subito ha preferito consacrarsi a una prospettiva interdisciplinare del culto a cui si sentiva vocato: anziché sognare di diventare virtuoso della tastiera o dell’archetto, si è avventurato per anni in esperimenti alchemici miranti a combinare l’Arte dei Suoni con la prosa letteraria, il teatro, la poesia, la corporeità, il gioco, i piaceri della tavola e la pittura.