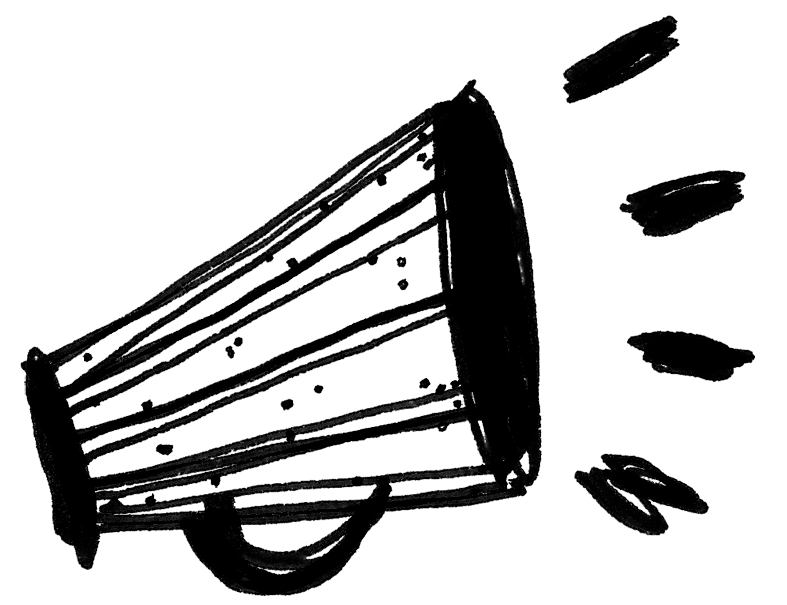Tutto cambia
Intervista a Vera Gheno
La lingua è uno strumento indispensabile di cui ci serviamo quotidianamente per comunicare, interagire con gli altri e con noi stessi e per entrare in relazione con i nostri pensieri e con la realtà che ci circonda. Nulla di ciò che la lingua ci permette di raccontare è rimasto o è destinato a restare uguale a se stesso. Di conseguenza, non dovrebbe essere naturale che anche la lingua sia in continuo e inevitabile cambiamento?
L’intervista con Vera Gheno è un invito alla consapevolezza: a prendere in mano le redini di una lingua che usiamo, ci appartiene e, quando ci sembra opportuno, possiamo contribuire a cambiare.
Durante i nostri laboratori, noi Ludosofici chiediamo spesso ai bambini chi, secondo loro, abbia inventato le parole: la risposta più comune è “Dio”. Questo dà l’idea di quanto la lingua sia percepita come qualcosa che ci è dato e che subiamo in modo quasi passivo. Hai qualche proposta e/o suggerimento affinché sin da piccolissimi i bambini siano consapevoli del potere che ciascuno di noi ha nel creare nuovi mondi grazie proprio al linguaggio e alle parole?
Anch’io, nei miei incontri, chiedo spesso chi abbia inventato le parole e devo dire che, ultimamente, oltre a “Dio” anche “gli influencer” è diventata una risposta piuttosto frequente, il che la dice lunga su chi sia percepito come potente.
In ogni caso, io penso che il modo migliore per far capire ai bambini il potere che hanno sia spiegarglielo, esattamente come ha fatto la maestra Margherita quando il suo alunno Matteo ha coniato la parola ”petaloso“. Seguendo questo esempio, si dovrebbero fare lezioni di neologia e rendere chiaro che siamo noi a dare i nomi alle cose, come del resto afferma anche la Bibbia: Dio crea gli animali e le piante e li porta davanti all’uomo perché sia lui a nominarli. È importante sottolineare che questa operazione di “onomaturgia”, come la chiama Bruno Migliorini, si perpetua e, perciò, riguarda tutti, non solo gli uomini antichi.
Nominare la realtà ci permette di capirla e di organizzarla, di comprenderla e soprattutto di raccontarla: è solo grazie ai nomi che possiamo staccarci dallo hic et nunc e parlare anche di ciò che non è presente davanti a noi.
I bambini sono perfettamente in grado di comprendere una simile spiegazione, ma, per renderla ancora più evidente, si possono anche fare degli esperimenti. Per esempio, potrebbe essere mostrato un oggetto esotico o così vecchio che difficilmente avranno visto e, a partire da esso, proporre due diverse attività. Da un lato, non conoscendone il nome, si potrebbe provare prima a non nominarlo, sperimentando quanto sia difficile parlarne con coloro che non l’hanno visto, e poi a dargli un nome, giocando con le suggestioni che l’oggetto ispira (per una cosa dall’aspetto tondeggiante, magari, si sceglieranno nomi pieni di m, b o d, così come per un oggetto capace di produrre un suono acuto si opterà per una parola con tante i). Dall’altro, o in seconda battuta, si potrebbe rivelare come si chiama quello strano oggetto e spiegare la ragione di quel nome.
Questo tipo di conoscenze rischia di passare in secondo piano, ma è parte integrante della nostra quotidianità. Per questo è importante evidenziarle e sistematizzarle: solo così nei bambini può svilupparsi quella consapevolezza, estranea alla maggior parte degli adulti, che riconosce la possibilità di coniare nuove parole. Del resto, se nessuno insegna che la lingua cambia continuamente, è normale turbarsi nell’udire nomi che prima non c’erano.
In questo periodo stai parlando molto della Schwa. La cosa che mi affascina maggiormente della Schwa è l’aver fatto corrispondere un bisogno di inclusione a un segno grafico già esistente ma che, fino ad ora, aveva una funzione prettamente fonetica. La nostra newsletter si rivolge soprattutto a insegnanti ed educatori che lavorano con bambine e bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria. In modo molto attento, hai evidenziato come una novità di questo tipo comporti delle insicurezze e delle oggettive difficoltà di lettura per una consistente fetta di popolazione, anziani e dislessici in primis. Se non si tiene conto di questo e si introduce la novità in modo indiscriminato e talvolta prepotente, paradossalmente un’operazione inclusiva rischia di diventare ancor più discriminante per molte persone.
Come fare, soprattutto quando si ha a che fare con i più piccoli, a trasmettere l’idea che attenzione, precisione e cura nella scelta delle parole siano azioni gentili e di accoglienza verso il nostro amico/a, compagno/a? Visto che le parole sono azioni, quali indicazioni ti sentiresti di dare?
Per prima cosa, vorrei fare una precisazione. Ad oggi parliamo dello Schwa, al maschile, perché, almeno per ora, non è una lettera: è un simbolo dell’alfabeto fonetico internazionale. È allora importante chiamarlo come hanno sempre fatto i linguisti, che di questo simbolo si occupano.
Quanto a me, io non ho fatto niente di speciale. Non ho lanciato alcuna vera proposta. In un mio libro uscito a fine 2019, Femminili singolari, accennavo allo schwa in maniera più o meno scherzosa, parlandone per non più di dieci righe. Il polverone è esploso dopo che mi sono espressa a favore dello schwa per la traduzione del libro di Marcia Tiburi Il contrario della solitudine, che, nell’originale portoghese brasiliano, ricorre alla forma inclusiva todes – diversa da todos e todas – estranea alla grammatica ufficiale.
Nel luglio 2020 Mattia Feltri ha pubblicato un articolo dal titolo “Allarmi siam fascistə” in cui si riferisce a un’accademica della Crusca che, su Facebook, proponeva di abolire i generi e usare lo schwa. Era evidente che si stava riferendo a me, dato ciò che avevo detto pubblicamente qualche giorno prima, anche se a quel tempo non lavoravo più per la Crusca, non sono mai stata un’accademica e la mia idea non è mai stata quella di eliminare modi di esprimersi, quanto, semmai, di aggiungerne. Tuttavia, non importa quante informazioni false fossero contenute in quell’articolo: la notizia, data in quel modo, ha eccitato i pregiudizi e ha dato vita alla vulgata che è ancora oggi in circolazione.
In realtà, ben prima che ne parlassi io, sul sito Italiano Inclusivo, tenuto da Luca Boschetto, già dal 2015 compare una vera e propria proposta, strutturata e diversa in cui si suggerisce di utilizzare lo schwa breve per il singolare e lo schwa lungo per il plurale. È una soluzione differente da quella adottata dalla casa editrice effequ, che ha optato per un solo simbolo, uguale per singolare e plurale, e che si rivela sufficiente per una lingua come la nostra, mezza flessiva, in cui il contesto chiarisce il numero dei soggetti coinvolti.
L’attenzione allo schwa nasce dal mio incontro con persone che si definiscono non binarie, genderfluid, genderqueer, agender o intersex. Si tratta di persone che, davanti a una lingua come l’italiano, il francese, lo spagnolo o il tedesco – lingue che in linea di massima non hanno il neutro e, anche laddove l’abbiano, lo usano solo per cose precise –, provano disagio, poiché non riescono a flettere su di sé la lingua. Lo schwa è una delle tante soluzioni nate dal basso nei circoli che si interessano a queste questioni, ovvero i collettivi LGBTQ+, i gruppi transfemministi, etc. Alternative allo shwa sono l’“*”, la “|“, la “@”, la “U”, la “X”, l’”’” o la doppia terminazione (ad esempio: carei tuttei). Sono convinta che in ogni caso si tratti di soluzioni ponte: tentativi di superare un aspetto della nostra lingua che ha funzionato per moltissimo tempo, ma che non può che essere messo in dubbio se posto di fronte alla questione delle persone non binary.
Per secoli abbiamo considerato la società divisa in maschi e femmine ed esclusivamente eterosessuale. Poi, nel corso del tempo, ci siamo resi conto che l’omosessualità non è il male e, sempre più velocemente, sono emersi molti tipi di diversità che hanno messo in crisi il paradigma normocentrico. Non è strano, quindi, che anche sul fronte linguistico ci sia tutto questo fermento. E sono dibattiti che non devono spaventare coloro i quali siano del tutto disinteressati a questi contesti: non si tratta di imporre soluzioni a nessuno, ma di prendere atto della necessità di autonominazione di una minoranza.
Io credo che non si debba parlare di gentilezza e di accoglienza, però. Se vogliamo davvero smontare il paradigma normocentrico, non dobbiamo pensare di essere i fortunati che concedono gentilezza e accoglienza. Dobbiamo semplicemente constatare che chi, per qualunque ragione, è diverso, ha tutto il diritto di ricercare la propria felicità anche attraverso l’autodeterminazione linguistica. Se non assumiamo questo punto di vista, saremo sempre convinti di essere i “normali” che si vantano di tollerare chi tanto normale non è. Già Pier Paolo Pasolini, negli anni Settanta, aveva definito “tolleranza” un termine ipocrita, che nascondeva l’atteggiamento tipico di chi vuole tenere buoni buoni tutti i diversi ai margini della società. Ecco, noi non vogliamo questo: aspiriamo a quella che Fabrizio Acanfora, in un suo bel saggio, definisce la convivenza delle differenze, dove il sentirsi diversi è reciproco e, di conseguenza, reciproco è lo sforzo che costituisce ogni relazione all’interno di una società. Non c’è nessuno che normalizza un altro, nessuno nella posizione di inglobare, accogliere o tollerare un altro.
Basaglia diceva: «Da vicino nessuno è normale». Mi sento di sottoscriverlo.
In una recente intervista parli di ritmo tra pieno e vuoto nella comunicazione. Sembra però che il vuoto spaventi sempre molto e ci sia sempre il bisogno di riempire.
La paura svanirebbe se le persone conoscessero la teoria della cosiddetta dieta mediatica. Non l’ho inventata io e in America se ne parla già da un po’ di tempo.
Il nostro benessere fisico dipende da una dieta varia, che alterna momenti in cui ci nutriamo a momenti in cui non mangiamo: ci viene detto e sappiamo che non possiamo mangiare continuamente. Ecco, con le parole è lo stesso: se vogliamo adottare una dieta equilibrata, dovremo variare i contenuti a cui attingiamo – libri (più e meno elevati), social, fumetti, TV, cinema, poesia, serie, etc. – e non dimenticarci, a volte, di ricorrere a qualche istante di silenzio, in cui non si produce né si consuma nulla. Il silenzio ci è indispensabile per digerire tutto ciò che abbiamo incamerato, per elaborarlo e per pensare a quel che butteremo fuori.
Il silenzio non è assenza di comunicazione, ma una forma di comunicazione: è in grado di dire molto e crea lo spazio interiore per il movimento tanto di fruizione quanto di produzione dell’informazione. Se questo spazio non c’è, viviamo in una centrifuga comunicativa enormemente stressante (ecco perché poi, di tanto in tanto, ricorriamo allo yoga, alla meditazione silenziosa: nulla di male, ma perché non abituarci a riservare al silenzio momenti non straordinari della nostra quotidianità?).
Mi sembra che la lingua che parliamo sia refrattaria a essere stanziale e statica. Non dovremmo forse adattarci a seguirne la corrente, così da non rischiare di affogare?
Solo quando una lingua muore è possibile musealizzarla. Quando è viva, la lingua è in movimento ed è questo l’aspetto che preferisco. Ecco perché sono intrinsecamente contraria al progetto del museo della lingua. Capisco che si possano allestire delle teche dedicate al passato linguistico, ma credo sia più importante insistere sulla mutevolezza della lingua. Per questo, preferirei una mostra perenne del cambiamento linguistico in cui con sale sui neologismi, sui linguaggi giovanili, sugli esperimenti della Trap, sul Futurismo e, ovviamente, sul linguaggio inclusivo. Insomma, credo ci si dovrebbe concentrare su ciò che devia dalla norma, che a sua volta non è un dato indiscutibile, ma nasce dall’uso, che non è sempre uguale.
Ogni lingua viva cambia, perché il principale strumento che abbiamo non per fare letteratura, né per fare bella figura, ma per vivere, per interpretare la quotidianità. Noi siamo le parole che usiamo: grazie alla lingua compiamo atti linguistici individuali, ma anche collettivi. Ci è indispensabile per marchiare il mondo, che, come noi, è in continuo cambiamento. È del tutto normale, dunque, che si sia immersi in un perenne cambiamento linguistico.
Purtroppo, insegnare il carattere mutevole della lingua è più difficile che insegnarne la staticità: l’educazione linguistica spesso coincide con l’educazione all’uso della norma. La norma, però, di per sé è un’astrazione e ha senso solo se applicata nell’uso quotidiano, che richiede un continuo cambiamento. Immaginiamo cosa accadrebbe se guidassimo seguendo sempre e solo pedissequamente le indicazioni del libro su cui studiamo per prendere la patente: non avremmo la prontezza di evitare un incidente o di non inchiodare a uno stop in un contesto di ampia visibilità. La realtà linguistica è simile: chi parla, così come chi guida, sa e deve adeguarsi prontamente alla situazione.
La competenza linguistica è fatta di questa doppia consapevolezza: della norma, che solo conoscendo si può trasgredire; del perenne movimento e cambiamento della lingua, che è necessario cogliere per non vivere al di fuori del presente in cui siamo immersi.
Quando incontro studenti e studentesse di tutte le età, cerco sempre di ricordare loro che la lingua è nostra, non è qualcosa che appartiene ad altri: non è del grammatico, che la inserisce nei manuali di grammatica; non è dei docenti, che su di essa programmano verifiche e interrogazioni; non è, in generale, dei potenti, che, come diceva Don Milani, formalizzano la conoscenza linguistica a proprio beneficio. E con questo non voglio assolutamente suggerire che studiare non sia importante, al contrario. Se si vuole criticare e ribaltare il sistema, è necessario farlo da dentro: imparare le regole e così diventare a propria volta custodi attivi della norma. È un ideale, certo. Tuttavia, io sento fortissima l’anima democratica della lingua e credo che più siamo a essere consapevoli di ciò che può essere in nostro potere, meno lo consegneremo ad altri da gestire per conto nostro.
Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca lavorando nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter dell’istituzione. Insegna all’Università di Firenze, dove tiene da molti anni il Laboratorio di italiano scritto per Scienze Umanistiche per la Comunicazione, e in corsi e master di diversi atenei italiani. È autrice di articoli scientifici e divulgativi e per Einaudi ha pubblicato Potere alle parole (2019) e Le ragioni del dubbio. L’arte di usare le parole (2021).