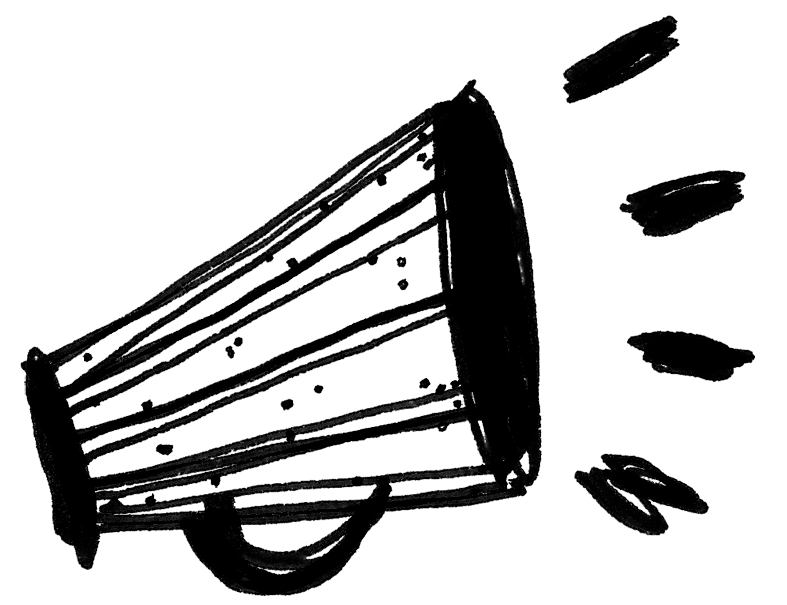Un big bang zitto zitto
Articolo a cura di Danilo Faravelli
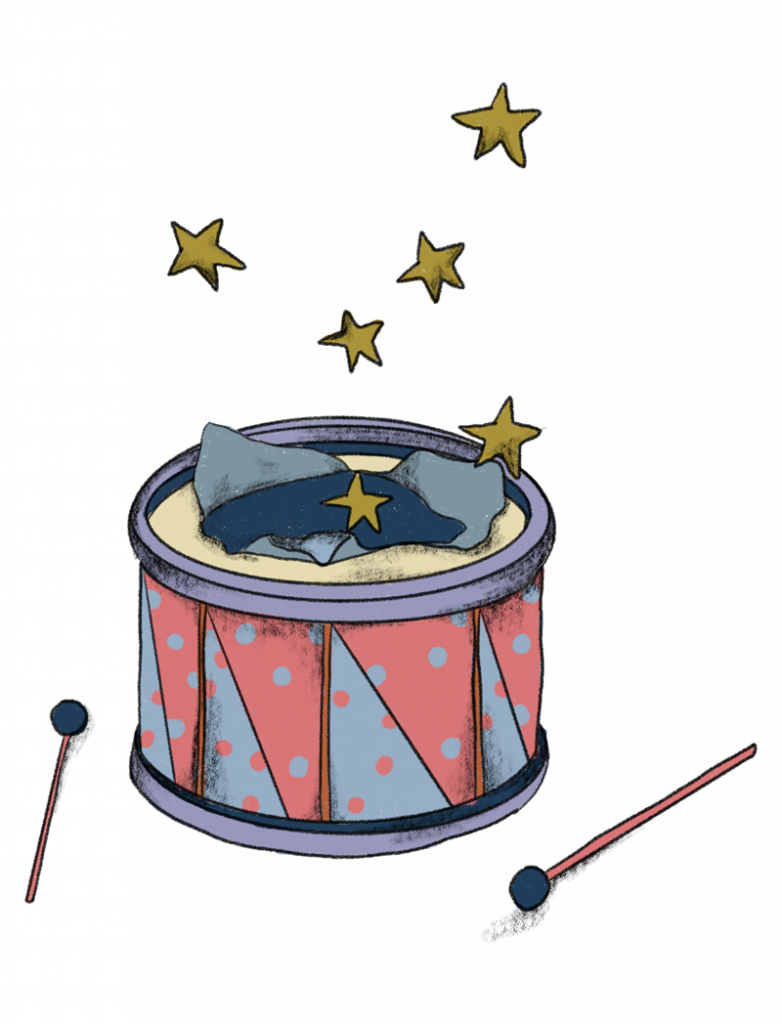
Quando sentiamo parlare di big bang, ovvero dell’esplosione che diede origine all’universo, la nostra ridicola immaginazione si avvita su se stessa in preda a una piacevole vertigine e subito comincia a perdersi nell’idea di un botto cosmico di potenza incommensurabile e di propagazione illimitata, senz’altro foriero di completo annientamento a danno delle facoltà uditive di chi fosse lì ad ascoltare. In questo nostro puerile modo di reagire, incapaci come siamo di sottrarci alle abitudini che regolano le nostre relazioni con la realtà che ci circonda, non teniamo conto del fatto che, in assenza di membrane timpaniche atte a vibrare in simpatia con l’aria scossa dal big bang (aria peraltro a sua volta assente), quella spaventosa esplosione cosmogonica non poté di fatto produrre suono alcuno. Infatti, aria e orecchio sarebbero stati generati essi stessi dalle conseguenze biochimiche di quel gran botto, il cui sconvolgimento – come ben sappiamo – è ancora lungi dall’aver esaurito la propria energia.
E possiamo forse pretendere che, trovandosi a svolgere il ruolo di sottoprodotto e comunque di parte integrante di un universo in espansione, i nostri sensi, in particolare quello dell’udito, comincino ora, di punto in bianco, ad accorgersi del proprio esserne espressione infinitesimale; ora, mentre vi sono immersi da milioni di anni?
Tutto questo valga per sottolineare fino a che punto aria, suono e udito rappresentino i termini inscindibili di un interessantissimo fenomeno di reciproca limitazione: laddove non c’è aria non si può dare fenomeno sonoro; laddove vi sia aria vibrante, ma non timpani pronti a farsi contagiare dalla sua elasticità, non vi sarà sensazione uditiva.
Passiamo ora ai livelli argomentativi più riposanti della concretezza ordinaria. Scendiamo ai livelli della realtà in cui il nostro orecchio, collegato a un cervello incline all’esperienza estetica, incontra quell’aria di tipo speciale che chiamiamo Musica, posta in vibrazioni da una voce gradevole e ben intonata o da un ensemble di bravi strumentisti fra loro ben affiatati. Quanti fattori dovremo considerare prima di emettere un giudizio di qualità su ciò che avremo ascoltato? Oltre alla bravura di chi avrà cantato o suonato, oltre all’eccellenza timbrica delle voci e degli strumenti chiamati a interagire, che ruolo dovremo chiederci abbia giocato l’aria fatta vibrare in quella specifica occasione da noi presa in esame?
Nelle cronache musicali del passato abbondano le allusioni al caldo torrido sopportato all’interno dei teatri d’opera assistendo a messe in scena nei mesi estivi, alla puzza di sudore promanante dai corpi poco avvezzi all’igiene quotidiana di ascoltatori riuniti in piccole sale da concerto, al ristagnare di micidiali cocktails di afrore a base di alitosi da tabacco fumato o masticato, di orinatoi a vaso non svuotati e di combustioni di legna da camino, di carbone da stufa, di olio da lampada e di lucignoli di candela.
Eccoci al punto: in che misura considereremo incantevole un concerto di Mozart, dopo avere valutato, oltre all’eccellenza del solista al pianoforte e alla squisitezza dell’orchestra ingaggiata per accompagnarlo, la qualità dell’aria eletta a fare da autostrada della traduzione in suoni del pensiero musicale del maestro verso la meta dei nostri timpani? Fatta la tara del condizionamento necessariamente prodotto dalla cornice ambientale offerta al nostro sguardo, è fin troppo facile prevedere in quale dei due seguenti casi risulti “più bella” una medesima musica composta impeccabilmente sulla carta pentagrammata, affidata a interpreti di provato talento e fatta viaggiare all’aria aperta. Primo caso: nel vibrare di aria densa e polverosa nel cortile di un cementificio alla periferia di una metropoli? Secondo caso: nel vibrare di aria cristallina e profumata di un giardino fiorito ai piedi delle Dolomiti?

Danilo Faravelli, nato nel 1953, si è appassionato alla musica d’arte negli anni dell’adolescenza. Sin da subito ha preferito consacrarsi a una prospettiva interdisciplinare del culto a cui si sentiva vocato: anziché sognare di diventare virtuoso della tastiera o dell’archetto, si è avventurato per anni in esperimenti alchemici miranti a combinare l’Arte dei Suoni con la prosa letteraria, il teatro, la poesia, la corporeità, il gioco, i piaceri della tavola e la pittura.